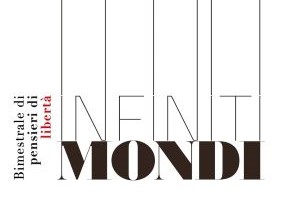E’ difficile, sotto l’emozione delle immagini crude di bambini sottratti alla vita, di malati, anziani, donne che trascinano povere cose con gli occhi pieni di terrore alla ricerca di posti sicuri, di città dilaniate e scheletrite, riuscire a riordinare le idee per una qualche riflessione su ciò che avviene in Ucraina.
Eppure in qualche modo è doveroso per tutti: per chi conta e definisce le sorti del mondo; per tutti noi il cui potere di intervenire a cambiare le cose è di poco superiore allo zero.
Certo, alla base del riaffacciarsi del pericolo di una guerra totale e per di più nel cuore di un continente che si era illuso di averla bandita per sempre (dimentico, però, di Sarajevo e di Monstar e degli stessi fuochi accesi nell’Ucraina orientale nel 2014) c’è una volontà individuale, un uomo che vuole rifare la storia per entrare nella storia a costo di farlo su una pila di cadaveri di uomini, donne e bambini inermi.
Altri devono rettificare il giudizio su Vladimir Putin. Noi dobbiamo purtroppo qui segnalare come facilmente, in un appannamento della cultura democratica dell’occidente, si sia potuto dimenticare che la differenza tra autocrate e dittatore sia esigua e che abbassare la guardia verso le autocrazie per ragioni di realpolitik può portare lontano, molto pericolosamente lontano…
C’è, certo, e tanto, del suo… Tanto da essere sufficiente perché su di lui non sia solo la storia a dover emettere un pesante giudizio ma perché prima di quello storico l’umanità possa registrare quello della Corte di Giustizia dell’Aja in quanto criminale di guerra, (come io mi auguro avvenga) …
Ma nessun autocrate è in grado di muovere guerra senza avere alle spalle, attivo o silente, il consenso della maggioranza del popolo su cui governa.
Ed è questo il punto: chiederci come il popolo russo sia oggi concorde, a parte una minoranza importante ma esigua, con il nazionalismo aggressivo e criminale del suo capo. E chiederci se questo sia una sorta di dato scontato di una non meglio precisata “anima russa” o non sia il frutto di fatti identificabili che, anche se possono affondare radici negli strati più profondi della sua storia, portano a maturazione i loro frutti venefici qui ed ora, sulla base di processi non antichi, ma recenti, pezzi di quella storia che abbiamo vissuto come cronaca.
E’ un’esigenza che riaffiora qua e là tra gli osservatori più intelligenti e meno disponibili a portare il cervello all’ammasso della vulgata “atlantista” imperante… Questo bisogno di capire le ragioni di ciò che accade sotto i nostri occhi si sta manifestando però in maniera del tutto insufficiente. E questo limite mi appare essere autolesionistico se il bisogno che abbiamo, come Europa, ma anche come pianeta Terra, è quello di trovare le vie per un assetto più equo nelle relazioni tra popoli e tra Stati e per questa via più in grado di assicurare un nuovo sistema di relazioni europee nel quale la sicurezza più che dalla deterrenza dei reciproci armamenti nucleari poggi su un nuovo assetto delle relazioni statuali fondato sul rispetto delle legittime esigenze di tutti.
Proviamo, allora a dire qualcosa di sinistra, qualcosa di fondato cioè su una verità storica. Proviamo caricandoci certo della doverosa autocritica per tutti gli errori di valutazione fatti nel passato, ma non per questo rinunziando al pensiero critico contro le verità di comodo del potere, senza temere di muoverci contro-corrente e anche scontando il rischio che la volontà di mantenere vivo un pensiero vero possa essere dagli altri distorta e rovesciataci contro, sfruttando l’emotività del momento.
Lasciamo allora scorrere la memoria ad un trentennio orsono.
Nel biennio 1991/1992 l’URSS implode. Giungono a maturazione i processi attivati da una lunga stagnazione, politica ed economica, nata a datare dal fallimento delle riforme kruscioviane del decennio ‘53/’63 per un verso e, per altro e combinati assieme, gli effetti devastanti della sconfitta in Afghanistan e la impossibilità a reggere la sfida costosa dell’ammodernamento degli armamenti…
Il popolo russo chiede benessere e democrazia, i terreni su cui si è consumato il fallimento storico del “comunismo realizzato”, ma l’occidente si guarda bene dall’aiutare il disperato tentativo di Gorbaciov di dare risposte e recuperare il tempo perduto.
Di fatto si conclude la “guerra fredda”, e con un vincitore indiscusso e assoluto, il capitalismo occidentale ed il suo modello e senza un “trattato di pace”.
Ecco, qui sta un grumo su cui la riflessione non sta avendo il coraggio di alzare la voce. La guerra vinta mette nelle mani dei vincitori il diritto a dettare le condizioni certamente ma quelle imposte, seppure scritte solo nei fatti, hanno lo stesso spirito di quelle che la Francia dettò per la Germania nel 1919 a Versailles, volendo o nolendo all’origine del fallimento di Weimar e dell’avvento di Hitler. E, a rifletterci bene, non molto diverse, se non nell’apparenza, da quelle imposte ai bolscevichi a Brest Litovsk nel 1917.
Si è trattato di condizioni umilianti per uno Stato che si è affermato come protagonista della storia da Pietro il Grande e non da ieri; mortificanti per ciascun russo, tali da eccitare il revanchismo che è un tarlo che scava nel profondo, e non per settimane e mesi, ma per anni e decenni.
La negatività non è nell’aver riconosciuto il diritto alla “separazione” delle repubbliche federate (paesi baltici, Ucraina, Moldavia, Bielorussia, per restare alla parte europea) e anche delle stesse repubbliche della federazione russa, cosa peraltro prevista dalla Costituzione dell’URSS e resa praticabile dalla legge gorbacioviana del 1990.
Una separazione, però, non può essere un atto unilaterale: settantacinque anni di storia comune non si cancellano con una croce su un si in un referendum. Essa provoca i suoi effetti su un complesso intreccio di relazioni non sempre di direzione univoca, economici, militari, culturali ma soprattutto di rapporti interetnici.
Fermiamoci a questi. La nuova linea di confine che dal nord finnico, il centro slavo, ungaro e rumeno ed il sud caucasico che viene a separare la Russia dai nuovi stati ex sovietici taglia nel corpo vivo di aggregazioni etniche minoritarie che sono, senza che nessuno le abbia consultate, spesso frantumate in stati diversi…
Qui un primo punto: le stesse ragioni che legittimavano la separazione degli Stati, allo stesso modo e con lo stesso valore legittimavano il ridisegno di confini o quantomeno meccanismi di tutela e di autogoverno delle minoranze etniche incorporate a forza in un vestito statale non tagliato a loro misura… E questo soprattutto in un contesto in cui il riferimento a “confini storici” è, il più delle volte, un non-senso se non ad inventarsi a proprio comodo origini che affondano nella notte dei tempi: vale per le repubbliche baltiche, vale per l’Ucraina, vale per la Bielorussia, prive di una propria storia politica nazionale se non a partire dagli stati fantocci costruiti dal trattato di Brest Litovsk, per la Moldavia la cui storia richiamabile era unitaria con la Romania, sempre solo per restare in Europa. I confini sono quelli amministrativi, nei fatti, dell’URSS, a loro volta essenzialmente ritagliati su una preponderanza dei dati meramente maggioritari di lingua e religione.
Non aver tenuto conto delle minoranze interne ai nuovi confini è stato uno dei limiti maggiori dell’”autodeterminazione”.
Eppure un esempio di come si sarebbe potuto disinnescare la mina era dato dalla soluzione trovata per il Sűd Tirol, il nostro Alto Adige, con gli accordi De Gasperi-Gruber del 5/9/1946 il cui elemento significativo, assieme all’ampia autonomia concessa, è di essere un accordo tra Stati e, di conseguenza, è il ruolo riconosciuto ad un altro Stato, l’Austria, una sorta di diritto di tutela per una minoranza che pur viveva nel confine italiano già a datare dal 1919.
Ma c’è un secondo punto, quello della sicurezza.
La fine della guerra fredda comporta con la dissoluzione dell’URSS anche quella del suo sistema di alleanze militari. Il patto di Varsavia il 31 marzo 1991 conseguentemente si scioglie. Il buon senso si sarebbe aspettato che le due dissoluzioni comportassero di conseguenza lo scioglimento della NATO che come sistema di alleanza occidentale ha, sin dalla sua nascita, lo stigma della “dottrina Truman”, della scelta fondamentale cioè della politica estera americana di operare anche militarmente per il contenimento del cosiddetto “espansionismo sovietico”.
All’ipocrita riconversione dell’alleanza non più motivabile con l’anticomunismo in una presunta “lega contro il terrorismo” poteva almeno corrispondere la disponibilità a farsi carico di almeno alcune delle ragioni russe relative alla sua sicurezza. Andava in questa direzione l’impegno chiesto da Gorbaciov di bloccare ogni allargamento dell’alleanza ad est. Posizione che, peraltro, fu alla base del consenso russo alla unificazione tedesca.
Ma “vea victis!”. Le condizioni di disfacimento delle strutture statali e militari della Russia fanno sì che l’occidente possa scegliere di umiliare l’interlocutore russo e allargare l’alleanza a Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Slovenia, e persino alle ex repubbliche sovietiche come Lituania, Lettonia e Estonia, il cui confine è a meno di 200 chilometri da Pietroburgo!
Ma, mi si obietta, “non è forse legittimo a qualsiasi stato sovrano scegliersi gli alleati che vuole ed armarsi come vuole?”
Io credo che sia legittimo, se altrettanto si riconosca che legittimamente un Paese confinante possa da tali scelte sentirsi minacciato. L’argomentazione, allora, è una pietosa foglia di fico: nell’ottobre del 1962 il mondo fu sull’orlo della terza guerra mondiale a causa del dispiegamento a Cuba (che lo aveva richiesto) di missili in grado di portare testate nucleari (peraltro dopo che gli Usa avevano fatto lo stesso in Turchia e dopo che avevano armato lo sbarco di esuli cubani alla Baia dei Porci per il legittimo governo cubano); gli Usa la ritennero una ravvicinata minaccia di guerra, un vero e proprio atto aggressivo e chiesero l’immediato ritiro dei missili. Il mondo ritenne giusta la posizione americana e avventata e provocatoria la mossa sovietica.
Allora la saggezza di due leader veri, malgrado i loro limiti, (Kennedy e Krusciov) trovò una onorevole soluzione: ritiro dei missili russi da Cuba in cambio del ritiro di quelli americani dalla Turchia e della garanzia statunitense dell’indipendenza di Cuba.
Questa saggezza è mancata ai paesi occidentali, soprattutto agli Usa, che proprio a datare dal crollo dell’URSS sembrano aver perso la bussola per una qualunque seria politica di grande potenza, come dimostrano i cul di sac in cui finiscono, ogni qualvolta tale funzione cercano di esercitarla anche con le armi (Irak, Afghanistan, Siria e Libia).
Ciò che colpisce, allora, di fronte alla crisi ucraina, è l’incapacità di avviare un negoziato vero, che lasci nell’immondizia gli errori dell’Occidente di questo ultimo trentennio e riprenda il filo dal punto in cui una diversa soluzione era possibile, una diversa strada la si poteva percorrere per garantire attraverso un sistema di garanzie internazionali:
a) l’indipendenza, la sovranità, l’intangibilità delle frontiere e soprattutto la sicurezza per tutti i Paesi dell’ex URSS internazionalmente garantite anche da un patto di intervento militare automatico in caso di aggressione, attraverso una zona demilitarizzata lungo tutti i confini europei della Russia;
b) il ridisegno condiviso delle frontiere per “riunificare”, ove possibile, minoranze etniche alla “nazione” di appartenenza e comunque, per etnie intercluse, sulla falsariga del patto per l’Alto Adige, una garanzia internazionale a forme ampie di tutela e di autogoverno.
Personalmente diffido della retorica europeista. Ma su un punto sono d’accordo con tanti osservatori: la crisi ucraina è il banco di prova per la possibilità che la UE cessi di essere un nano politico ed affermi con la sua autonoma e originale iniziativa il diritto-dovere di indicare una prospettiva percorribile per rifare dell’Europa fisica un campo di pace.
Spetta quindi alla UE trovare le strade di un percorso possibile, rivendicando con fatti un ruolo decisivo e primario, con proposte che facciano ammenda degli errori sin qui commessi e che siano comprensibili non solo per i Paesi occidentali o che guardano all’Occidente, ma anche per la Russia ed i suoi alleati.
Un autocrate, dicevo prima, una guerra non la fa se non ha il sostegno del suo popolo. Occorre allora privare Putin di questo sostegno, dando ai russi una motivazione per premere, per spingere il proprio governo a negoziati veri per una pace duratura.
Per questo occorrono grandi leader. Ma all’orizzonte, a parte papa Francesco, non ne appare nessuno.
Lucio Fierro