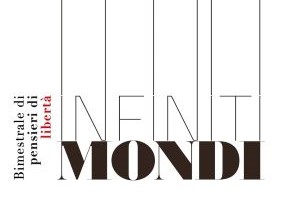80 anni dal 25 aprile 1945 non sono un periodo breve.
Infatti, in questo tempo tante cose sono successe: la nascita della Repubblica, la fine della sua prima strutturazione basata sui partiti, l’inizio e la fine della “guerra fredda” e poi, ciò che più di tutto deve preoccupare quando si celebra questa data, l’inizio della “guerra mondiale a pezzi” e il rialzare la testa delle destre reazionarie in tutto il mondo.
Gli 80 anni dalla Liberazione cadono, nell’Italia governata per la prima volta da una destra diretta erede del neofascismo, in un clima internazionale in cui lo sdoganamento dell’estremismo destrorso è giunto al punto in cui dal governo degli Stati Uniti possono partire endorsement a favore di forze neonaziste come AFD in Germania, confermando sempre più che le destre, al di là e al di qua dell’Atlantico (e del Mediterraneo), condividono un orizzonte di senso e di linguaggio comuni.
Tra gli elementi cardine troviamo la xenofobia, presente nella retorica di tutta l’estrema destra con la scusa di preservare l’identità nazionale, la purezza culturale o la stabilità economica, negli ultimi anni sviluppatasi anche verso il manifestarsi di identità e costumi sessuali che sfidano la struttura sociale e familiare tradizionale. Il successo di queste narrazioni spesso dipende dalla loro capacità di attingere a più profonde ansie relative alla perdita di controllo e di identità.
Le basi emotive del sostegno all’estrema destra sono infatti profondamente intrecciate con sentimenti come rabbia, risentimento, insicurezza e paura del declassamento, e le destre sanno sfruttare efficacemente i sentimenti di impotenza e vulnerabilità economica degli elettori. Inoltre, la narrazione della minaccia rappresentata da diverse minoranze – siano esse etniche, religiose, linguistiche o politiche – è un filo conduttore tra questi partiti, contribuendo a un più ampio “discorso della paura”.
E poi, la sfiducia nei confronti delle istituzioni sovranazionali, che ormai sta travalicando nell’esplicito indebolimento l’Unione Europea, da sempre bersaglio delle destre nazionaliste (e che pure, bisogna ammettere, prima con il suo ottuso dogmatismo ordoliberista e ora con l’enfasi militarista dei suoi vertici ne è stata buona alleata); ma anche la Corte Penale Internazionale, rea di aver messo in discussione l’operato del governo israeliano, e le Nazioni Unite, in cui il “Sud del mondo” ha forse troppa voce in capitolo rispetto a quanto gli alfieri della conservazione ritengono accettabile.
Dunque, tante cose sono successe dal 1945 a oggi ma possiamo vedere che la struttura portante del pensiero della destra non è cambiata molto: tradizionalismo, paura del diverso, sfiducia verso le istituzioni sovranazionali, approccio alle relazioni internazionali con la logica della potenza e del neocolonialismo. Troviamo tutto ciò nella retorica dei Trump, dei Meloni, dei Netanyahu, degli Orban, dei Putin e, purtroppo, di tanti altri, così come in quella di tanti leader del passato, il cui marchio sul mondo è stato quello della distruzione.
Ricordare tutto questo oggi, portare allo scoperto i fili che uniscono il tragico passato con l’oscuro presente, significa ricollocare la lotta partigiana nel quadro globale dello scontro, quello sì una vera battaglia di civiltà, tra le forze che volevano costruire un mondo imperniato sui diritti – tra cui, non ultimo, quello delle masse popolari e lavoratrici di essere protagoniste di uno sviluppo non basato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo – e quelle che, come unico principio, avevano la forza e la sopraffazione.
È la stessa battaglia che è in corso oggi, 80 anni dopo.
Lorenzo Fattori