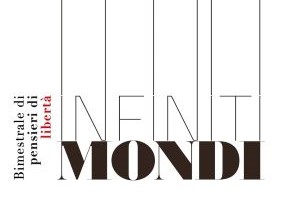Luigi Alfinito, docente liceale di lettere in pensione ha tradotto dal latino parti dell’Historia patria di Giuseppe Ripamonti che ha ispirato Alessandro Manzoni per i suoi Promessi Sposi ( edita nel 2019 da la Scuola di Pitagora (Napoli) col titolo La signora di Monza e altre storie patrie ), e ci propone qui una riflessione sulla sua utilità didattica.
Nella sua voluminosa Historia patria Giuseppe Ripamonti racconta, in latino, le vicende accadute nel milanese negli ultimi tre secoli, dal XIV fino ai primi decenni del XVII, l’eta’ a lui contemporanea.
Ripamonti era un canonico del duomo di Milano, faceva parte del seguito del cardinale Federigo Borromeo, al quale doveva l’ordinazione sacerdotale, la nomina di insegnante di grammatica (cioe’ di latino) e quella di Direttore della biblioteca ambrosiana.
L’ultima parte di questa sua opera è tutta una celebrazione delle virtù e della vita del cardinale, che si occupò della Monaca di Monza, dallo scandalo alla redenzione, e di quel signore fuorilegge che si convertì dopo un colloquio con lui.
Di entrambi i personaggi il buon canonico tace il nome e il casato per ragioni prudenziali, come del resto il Manzoni stesso, che ne i Promessi Sposi attribuisce alla monaca il nome fittizio di Gertrude e chiama l’altro “l’Innominato”.
La scelta dei passi riportati in questa breve antologia ripamontiana , con testo e traduzione frontale, e’ stata ispirata dal mio interesse per il Manzoni: capire come egli ha utilizzato la sua principale fonte storica e l’ha trasformata, non solo ci introduce nel suo laboratorio artistico, ma ci illumina pure sull’astronomica distanza culturale che separa il cattolicesimo controriformistico del cattolicesimo liberale e romantico: non per niente fra il seicento e l’ottocento è passato il “secolo dei lumi”.
Il mio discorso perciò verte ora sulla distanza tra Ripamonti e Manzoni, sia per la diversità degli esiti artistici (ricordiamoci che nel’ 600, prima della Scienza Nuova del Vico, la storigrafia e’ ritenuta letteratura), sia per la differente sensibilità umana e religiosa dei due scrittori, fermo restando che del Ripamonti storico Manzoni professa, in più punti delle sue opere, stima e rispetto.
Ebbene, con queste parole Ripamonti racconta la scoperta della tresca fra la monaca e il suo seduttore:
“Quella che era stata la causa prima di tutti i mali, già Principessa del borgo e del monastero, ora, persi l’onore e l’onestà, solo vergogna della stirpe e della famiglia di appartenenza, allontanata dal suo monastero, ospite ed inquilina in tutt’altra dimora, tenuta prigioniera, esule, screditata, disperata, impazzita, piena di ostinazione e di rabbia, assomigliava più ad un mostro che a una donna” ( p.41).
Come si vede, nel Ripamonti c’è tanta repulsione per il personaggio, che non lascia spazio alla pietà.
Eppure l’autore sa bene che “giovinetta… era stata portata in monastero non per sua volontà, come fu chiarito dagli eventi che susseguirono, ma per ragioni di interesse e per la nota preoccupazione dei potenti di tramandare intero il patrimonio, dando alle figlie femmine collocazione onorevole in convento”(p.29)
Ma nel seguito del racconto, lo storico non da’ importanza a questa crudele costrizione, che pure è all’origine della tragedia. Sentite ancora il ritratto che fa della monaca a p.35:
“era facile capire dalla postura, da quel che diceva e che pensava, come insieme con la verginità avesse perso ogni pudore. Non solo non era più illibata, ma nemmeno degna di restare in un convento di suore. Infatti aveva il coraggio di dire di aver preso il velo irregolarmente, non per vocazione, di essere stata rinchiusa nel chiostro dalla famiglia, senza il suo assenso, che non aveva l’età prescritta quando vi era entrata e nemmeno quando aveva pronunziato i voti, perciò non era valida la sua consacrazione. E come un’ indemoniata, nell’enormità della sua pervicacia, si fece scappare perfino queste parole, di doversi maritare a colui che essa aveva già prescelto”.
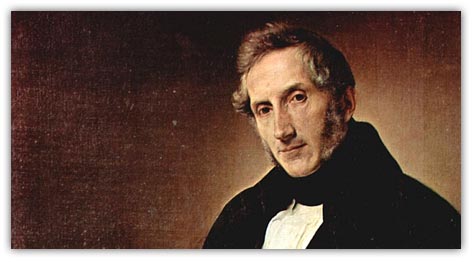
Come potete vedere, non c’è considerazione del dramma interiore vissuto da questa vittima della famiglia e del secolo, che invece Manzoni chiama “sventurata” con grande empatia.
Infatti trasforma il disprezzo che essa mostra della regola, quello che Ripamonti osserva dall’esterno, in un memorabile ritratto interiore, fatto di contrazioni dolorose della fronte, di occhi investigatori e sfuggenti, imploranti affetto e sprigionanti odio, noncuranza, travaglio, preoccupazione, come si legge nel cap. IX del romanzo.
Anche il ritratto che del Cardinale fa Ripamonti rimane esteriore, superficiale: la bellezza del personaggio è fatta derivare dal carisma dell’ufficio pastorale e dal decoro scenografico dei paramenti sacri.
Nel Manzoni, invece, la bellezza di Federigo è personalizzata, interiorizzata, spiritualizzata: deriva da pensieri solenni e benevoli, dalla pace interiore, dall’amore degli uomini, dalla gioia continua di una speranza ineffabile, come leggiamo nel capitolo xxiii del romanzo.
Ma torniamo alla signora di Monza. Il Ripamonti commenta la conversione finale della monaca con queste parole:
“tutta la nobiltà d’animo che ereditava dalla famiglia, sopita dalla depravazione e dall’ozio, venne fuori all’improvviso e con benefica contrizione indusse tutte le facoltà dell’animo a deplorare e a detestare quel che aveva commesso”
Come se la nobiltà d’animo si ereditasse per via genetica, come il titolo nobiliare!
Ma quale nobiltà d’animo abbia indotto il principe padre ad infliggere alla figlia tanta violenza psicologica, tanta crudeltà mentale, lo sa solo il Manzoni, che ha provato ad immaginare a quale oppressione può essere stata sottoposta l’infelice.

I cap. IX e X de i Promessi Sposi sono una piccola grande tragedia nel romanzo. Solo un romantico come il Manzoni poteva scardinare definitivamente il pregiudizio classicista e aristocratico che da secoli aveva identificato la nobiltà d’ animo con quella del blasone. Non a caso, il suo abbandono del classicismo giovanile coincide con la sua conversione religiosa. Ma nella sua polemica antinobiliare concorre in misura determinante la critica illuministica dell’ancient regime, che ha segnato la sua formazione giovanile e che egli ritrova inverata e spiritualizzata dal cristianesimo. Ripamonti ha fornito al Manzoni solo quelle coordinate storico-geografiche della vicenda, che gli sono indispensabili per accendere la fantasia artistica; Manzoni pero’ ne rovescia completamente il giudizio morale: la maggiore responsabilità di questa brutta storia ricade sulla famiglia, anzi sul padre.
E non sarebbe un capolavoro se il giudizio dell’autore non si trasformasse in un angoscia narrativa, in un pathos senza riscatto. Quanto più la ragione cerca di spiegarsi come può essersi svolta la vicenda, quanto più la fantasia immagina l’educazione deformante di Gertrude, la sua detenzione in rigoroso isolamento domestico, il ricatto morale per una innocente confidenza al paggio, la trappola psicologica di un affetto negatole al punto da indurla a mendicarlo, tanto più lo scrittore teme di avvicinarsi al punto-limite, nel quale la spiegazione della perversione potrebbe trasformarsi in giustificazione.
L’usanza delle monacazioni forzate per conservare indivisi i feudi era diffusa fin dal medioevo, spesso con la complicità interessata delle stesse istituzioni ecclesiastiche, con una connivenza chiaramente condannata dal Manzoni.
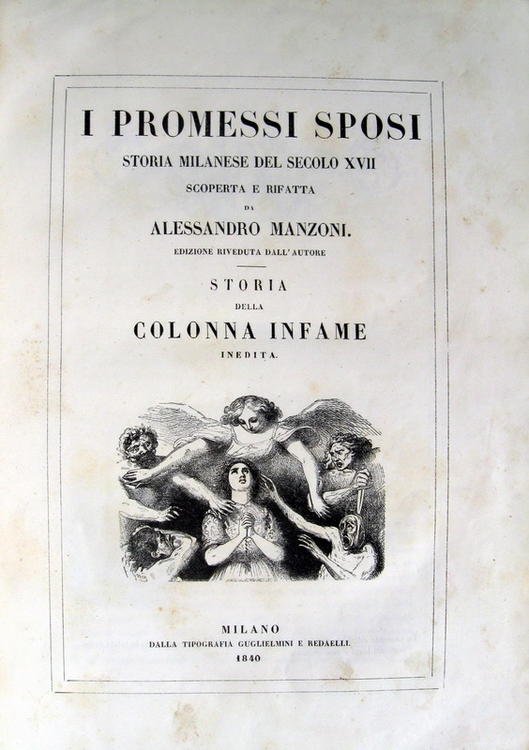
Il problema era già stato sollevato dal Diderot, che nel 1780 aveva pubblicato “ La religiosa”, un romanzo che prese spunto da un caso realmente accaduto. Lì l’enciclopedista francese intende condannare la condizione monacale come contraria alla natura umana e ai diritti della persona, illustrando il pervertimento che l’isolamento dalla società produce sulla persona stessa. Il Manzoni da giovane ha frequentato la letteratura illuministica e ne è rimasto colpito, recependone i principi libertari, egualiatari e solidaristici. Però da convertito si sente in dovere di dare una risposta cattolica alla condanna che Diderot ha fatto della condizione claustrale: la sua fede non gli consente nè la condanna del monachesimo, nè la deresponsabilizzazione del personaggio.
Perciò nel cap. X del romanzo lo scrittore conclude la tragica “preistoria” della monaca dicendo che la religione cristiana, da qualunque parte uno s’accosti ad essa, fornisce gli strumenti del riscatto e gli elementi di conforto per accettare uno stato di cose che non si può modificare.
“Con questo mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l’infelice si dibatteva in vece sotto il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e le scosse”.
L’autore ha dimenticato che nel capitolo precedente ha scritto che “ la religione, come l’avevano insegnata alla nostra poveretta, … non bandiva l’orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva”. Cioè, privata della sua essenza d’amore e ridotta a strumento di privilegio di classe, ad appagamento dell’orgoglio, a soddisfazione mondana, la religione non poteva darle una vera consolazione. Il Manzoni mostra lucida consapevolezza del problema educativo, ma non della contraddizione nella quale è incorso ritenendo sempre aperta la possibilità delle consolazioni religiose. Gertrude è l’unico personaggio del romanzo sul quale il giudizio morale dell’autore vacilla, oscillando tra la comprensione e la riprovazione. Perchè l’illuminismo ha posto con forza il problema educativo come determinante per la formazione e lo sviluppo della persona. Ricordate Rousseau?
“ L’uomo nasce buono, la società lo fa diventare cattivo!”
E il Manzoni sa che a Gertrude è stato inculcato a tal punto l’orgoglio di casta, che la religione stessa le viene insegnata come strumento di privilegio sociale: “quando sarai madre badessa, comanderai a bacchetta! Il sangue si porta per tutto dove si va”
Non solo, ma la crudeltà di cui è fatta oggetto, quando rifiuta lo stato monacale, serve solo a scatenare in lei i sentimenti peggiori: la rivalsa, l’invidia, la cattiveria e l’indebolimento della volontà e dell’autostima, fino a cedere a ricatto del padre a titolo di espiazione. E finirà col cedere anche al suo amante collaborando, con grande rimorso, al rapimento dell’innocente Lucia.
“Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, contro cui non divien forte se non chi se ne ribella interamente”.
Solo l’Innominato spezzerà la catena di delitti per non esserne prigioniero; questo perchè la natura gli ha dato volontà impetuosa, sicurezza d’animo, imperturbata costanza e la vita gli ha concesso l’opportunità di esercitare queste energie, che a Gertrude sono state negate sia dalla sua natura volubile, fantasiosa, vanitosa, sia dalla sua condizione di predestinata sociale alla reclusione: nessuno mai le comanda apertamente di prendere i voti (erano previste pene severe per queste costrizioni), ma tutti si comportano come se quello fosse il suo destino, tanto che da piccola si credeva nata già monaca.
Ora queste riflessioni non intendono dare un giudizio di assoluzione, tanto meno di condanna del personaggio: mirano solo ad evidenziare le resposabilità della famiglia e della società, che possono di fatto azzerare la libertà individuale impedendone l’esercizio. Infatti ognuno di noi diventa quale egli stesso si costruisce autodeterminandosi sulla base delle sue inclinazioni naturali e delle sue scelte consapevoli, oltre ad essere il prodotto dell’ambiente familiare e sociale. Perciò Manzoni non da’ solo l’avvio al romanzo storico e psicologico, ma anche al realismo ambientale. Per realismo non dobbiamo intendere un’improbabile impersonalitaà oggettiva della narrazione e nemmeno l’attenzione alla vita degli umili (come se le classi borghesi e aristocratiche fossero meno reali dei proletari e degli emarginati), ma piuttosto i condizionamenti deformanti che il personaggio subisce dal contesto socio-familiare.
Questo tipo di realismo è solo ottocentesco: cerchiamo di capirne il perchè.
Un esempio di educazione deformante: Rosso Malpelo, nell’omonima novella del Verga, è un ragazzo cattivo perchè ha i capelli rossi, ha sentenziato la comunità di appartenenza, che alleva questo piccolo orfano minatore a suon di botte. Sicchè quando a lui più adulto viene affidato un bambino al quale deve insegnare il lavoro in miniera, egli lo picchia a sangue senza motivo, immaginando di fare il suo bene, affinchè impari la dura legge della vita: subire quando si è incudine, cioè sottoposto, battere quando si è martello, cioè capo.

Il mondo antico ha rappresentato la vita degli umili quasi sempre in termini comici o idilliaci, osservava Erich Auerbach in un famoso capitolo di Mimesis, quello su petronio arbitro.
L’illustre studioso ne individuava il motivo nella rigorosa separazione degli stili, vigente nella letterature antiche, in virtu’ della quale la rappresentazione tragica è riservata alle classi sociali alte, come e’ codificato dalla poetica di Aristotele.
Ora mi permetto di osservare che probabilmente il motivo della trattazione comico-idilliaca degli umili nel mondo antico è forse più profondo di un mero criterio retorico-stilistico. Prima della rivoluzione industriale sette-ottocentesca, che determinò la concentrazione di emarginati nelle periferie di città come Parigi e Londra, la povertà generalmente non rappresentava un problema: da Leonida di Taranto fino al Rinascimento e all’Arcadia, i contadini, i pescatori e i pastori, che vivevano nel loro ambiente naturale, sembravano autosufficienti, quasi sempre contenti del poco che avevano.
L’organizzazione produttiva pre-industriale sviliuppò perciò un’ideologia dualistica dell’uomo, come un composto di necessità materiali ininfluenti e di una realtà spirituale considerata una variabile indipendente, cioè non soggetta alle incrostazioni, alle deformazioni e agli abbruttimenti operati dal contesto ambientale. Per l’epicureismo il cinismo, lo stoicismo, il cristianesimo, il platonismo si può essere poveri ma contenti, schiavi ma liberi dentro, poveri e schiavi ma santi, malati, incarcerati e torturati ma felici. Perciò la rappresentazione di condizionamenti ambientali sfavorevoli non è quasi mai tragica o problematica.
Quand’è che lo diventa? Quando l’attenzione illuministica al problema educativo dapprima, e successivamente il materialismo ottocentesco di Feuerbach e Marx, nonchè le ricerche positivistiche sull’unità psicosomatica dell’essere umano, cominciano a considerare determinanti per la formazione del carattere e della personalità le condizioni ambientali.
Queste erano snobbate dagli stoici antichi come “quelle che non dipendono da noi”. Quando però si comprende che esse, pur non dipendendo da noi, possono incidere profondamente sulla nostra formazione spirituale e sul nostro destino di bontà o di cattiveria, di felicità o di infelicità, allora la rappresentazione della realtà diventa tragica e problematica. Così ne I Miserabili di V. Hugo, come in certe pagine di C. Dickens, di E. Zola e di H. De balzac, troviamo personaggi brutti, sporchi e cattivi, capaci di suscitare pietà e paura, come una vicenda tragica, o sentimenti di protesta sociale.
L’altro personaggio storico importante, che il Manzoni attinge dal Ripamonti, è l’Innominato, del quale il canonico ci dice ben poco: questo signore nobile e ricco, che ha abbandonato il consorzio civile per darsi al banditismo vivendo in un castello di confine con i suoi sgherri, dopo un colloquio col cardinale, si converte. “che cosa si dissero, nessuno di noi l’ha mai saputo” dice il Ripamonti, che era al seguito del cardinale, ma e’ certo che da allora quell’uomo mutò radicalmente la sua vita.
La conversione del personaggio li ha un taglio agiografico, quello delle vite dei santi, per cui quest’uomo è un demonio prima della conversione e un angelo dopo. Quando Ripamonti ricorda di aver conosciuto personalmente questo signore ormai inoltrato negli anni, sembra bensì proporlo in termini bipolari, di aggressività naturale tenuta a freno da una mitezza imposta, ma sostanzialmente queste due polarità restano estranee l’una all’altra e sono costrette a convivere grazie al prevalere della mitezza sull’aggressività. La genialità del Manzoni consiste nell’avere riportato le due polarità contrapposte all’unità della coscienza morale, la quale non mortifica l’energia naturale, ma la guida verso un orizzonte d’amore, di speranza, di pentimento.
E’ vero che nelle parole qui riportate di Federigo il soggetto operante è Dio; ma l’azione divina passa necessariamente attraverso il riconoscimento della coscienza, la confessione, la preghiera: “che cosa potà fare Dio di voi, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l’imploriate?” Dice il cardinale dell’Innominato.
Del resto, una trasformazione così radicale e profonda non si sarebbe attuata, se l’Innominato non avesse provato già da tempo un insoddisfazione, una scontentezza di se’ che, ponendogli interrogativi sul senso stesso della sua esistenza, minava alla base il suo sistema di vita. L’incontro col cardinale, come il turbamento provato alla vista di lucia, non ha fatto altro che accelerare il processo già avviato.
Il Manzoni sa ben ritrovare il bene nel male e il male nel bene, in questo guazzabuglio del cuore umano, cioè i germi dell’uomo nuovo nell’uomo vecchio e la continuità caratteriale dell’uomo antico nell’uomo redento, secondo il paradigma di Ludovico-Cristoforo, che la lezione magistrale di Luigi Russo gia’ individuò.
Da giovane l’Innominato “allo spettacolo di tante prepotenze…,alla vista di tanti tiranni, provava un misto sentimento di sdegno e d’invidia impaziente”. Il senso della sua superiorità prevalse allora sull’esigenza nativa di giustizia: egli volle superare i prepotenti con le loro stesse armi, visti i ritardi, le inefficienze, le collusioni della giustizia umana e non riconoscendo la giustizia divina. Diventato così una sorta di giustiziere privato, sentiva talvolta benedire il suo nome dai poveri ingiustamente vessati dai signorotti, ma quel che più gli premeva allora era l’affermazione della sua assoluta superiorità, per dimostrare la quale compiva imprese delittuose impossibili ad altri.
C’è in questo “selvaggio signore” un profondo disagio ambientale per tutte le ipocrisie del suo secolo, un disgusto che egli manifesta negli insulti lanciati all’indirizzo del governatore spagnolo quando finisce col mettersi fuori legge: e’ il primo “vaffa” della storia. Eppure, che gli mancava, visto che era ricco e nobile? Non poteva godersi gli agi della sua condizione? Senza voler dare valenza ideologica al suo rifiuto di quella società ingiusta ( l’Innominato non è un intellettuale), comprendiamo che c’è in lui un senso nativo della giustizia, che lo induce al disgusto per tutto il contesto sociale nel quale vive; è solo necessità di potenza che gli fa vincere la naturale ripugnanza per il delitto. Ma quella ripugnanza tornerà a farsi sentire quando il suo disagio ambientale si trasformerà in un disagio esistenziale, con l’avanzare dell’età, ma soprattutto quando capirà che, per dimostrarsi onnipotente, s’è trasformato in servitore di quei tirannelli mediocri e ipocriti che più disprezza, come don Rodrigo perchè non hanno, come lui, il coraggio delle loro azioni.
L’inizio del pentimento parte da uno scatto dell’orgoglio risentito, dalla consapevolezza della sua superiorità più che dalla paura dell’inferno. Ma quel che gli fa rasentare la disperazione e il suicidio è l’identificazione della sua esistenza con la serie cosi’ numerosa di tutte le scelleratezze commesse: “eran tutte sue, eran lui!”
A noi non resta che ammirare la gradualità dei passaggi mentali e la naturalezza di questa conversione, soprattutto la verosimiglianza psicologica di un personaggio del quale il Manzoni ha appreso il mutamento nei termini del tutto miracolistici e taumaturgici del Ripamonti. Trovandosi di fronte ad un evento quasi inverosimile in termini umani, ma accertato personalmente da uno storico di rispetto, Manzoni s’è adoperato per inverare il certo: ha cercato cioè di rendere credibile, in termini storico-sociali e psicologici, anche per un lettore laico, quel che il credente vede come il frutto della grazia divina.
Il cosiddetto giansenismo del Manzoni, se e’ mai esistito, può ben rimanere circoscritto al rigorismo morale, al rifiuto di ogni compromesso della fede con la politica; ma non ha assolutamente niente a che fare con la predestinazione, tanto forte è nello scrittore l’esigenza dell’indagine razionale e la fede nella libertà umana, senza escludere con questo l’intervento divino.
Naturalmente, il Ripamonti è al di qua del dibattito sul libero arbitrio, acceso qualche anno dopo di lui dai padri solitari di Port-Royal: più volte egli celebra l’intervento della grazia soprannaturale, ma senza metterla problematicamente in rapporto col libero arbitrio dell’uomo.
E noi dobbiamo essere grati al Ripamonti per due motivi:
per averci lasciato testimonianza diretta del suo tempo, che non è poco, e per aver stimolato il genio creativo del Manzoni, che forse è il suo merito più grande.
Luigi Alfinito