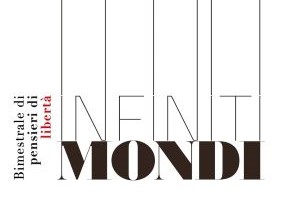Gli scheletri di Scotto
L’ambito di immagine nel quale muove Aniello Scotto è riconducibile a quell’ampio e, per certi versi, difforme movimento di liberazione creativa delle forze psichiche più profonde, che ebbe in Breton il suo teorico e in Freud il padre che rinnega i propri figli. Della pittura surrealista ritorna un interesse per il corpo nella sua duplice connotazione di segno e pulsione vitale e di visione anticipatoria di disfacimento e per questo motivo riportato a uno schema di ironia macabra, di carnevale spettrale, come accade nelle figurine quasi ritagliate di scheletri filiformi. Su questo itinerario si potrebbe risalire anche più indietro perché se il punto più vicino è quello della pittura e della grafica surrealista, ad esempio in certe ibridazioni e deformazioni tra Dalì ed Ernst, e quello forse troppo lontano ricorda i grilli medioevali e la pittura di Bosch, bisognerà almeno recuperare la matrice simbolista. Qui prende l’avvio la frizione insanabile tra la sfera delle pulsioni e dell’ancestrale rapporto col naturale, considerato nella sua effusione organica e vitale e le pratiche che caratterizzano i modi di vivere delle società moderne e urbanizzate. Ensor, Simberg, Rops sono i nomi più evidenti che si collegano all’attività di Scotto, perché fanno collidere il dato di una pulsione vitale con i vincoli e i tabù dei modi di aggregazione sociale, facendone emergere una sintesi di macabro disfacimento.
Gli scheletri di Scotto alludono a questa contraddizione: personaggi grotteschi, che emergono da regioni psichiche profonde e si presentano nella loro evidenza di tracce residuali di un vissuto comune a ciascuno. Le incisioni, secondo una declinazione di tecniche, li mostrano come grovigli filiformi in cui è il dettato del segno grafico a dominare, o in un’atmosfera di disgregazione pulviscolare che ne accresce il senso di evanescenza.
Massimo Tartaglione