Era un signore d’altri tempi, Franco Di Mare, uno di quelli che nascono di rado e soltanto a Napoli. Amava le donne e da loro era riamato non tanto per la sua indomita galanteria ma perché sapeva ascoltare. E poiché sapeva ascoltare senza cedere all’ingiuria del pregiudizio, era diventato anche un grande giornalista rimanendo sempre e comunque sè stesso. Con una carriera folgorante come la sua avrebbe potuto permettersi quella boria che molti inalberano a vanvera. Invece no, lui degli stendardi da parata non sapeva che farsene. Amava la vita, che è una cosa decisamente più complessa di qualsiasi mestiere, e mai avrebbe pensato che proprio lei lo avrebbe tradito alle 17,17 di un venerdì 17. Se l’avesse immaginato, si sarebbe lasciato andare a una risata – una delle sue, contagiose come il morbillo – dal retrogusto apotropaico.
Chi conosceva Franco sa quanto abitasse il mondo da napoletano, al punto che la lunga permanenza a Roma non aveva scalfito di un’oncia l’accento dialettale, quasi che la sua voce fosse una carta d’identità impossibile da sgualcire. Ma era napoletano anche nell’elegante leggerezza – che però si venava di autentica passione dinanzi alle traversie e alle scelte di campo -con cui attraversava le guerre o le cronache della sua terra. La polvere delle disgrazie, compresa l’ultima, non gli ha mai imbrattato l’abito. E tantomeno lo sguardo. Scrivo di lui oggi, in compagnia di un dolore che non s’attenua, perché ho perso un amico fraterno con cui ho condiviso anche un tratto di cammino sulle pagine di questo giornale. La sua rubrica “Sarò Franco” è stata a lungo uno degli appuntamenti più attesi dai lettori e la conservo tra i doni più preziosi che ho ricevuto da quando dirigo il Corriere del Mezzogiorno. Ma è altro che mi ha spinto a scrivere queste righe, qualcosa che valica il ricordo privato di un amico scomparso e si posa ai bordi di una foto ingiallita nella quale s’intravede, sempre più sbiadito, il profilo di una Napoli lontana, irrimediabilmente straniera nel presente.
Quell’istantanea ritrae un piccolo appartamento al secondo piano di via Cervantes 55 zeppo di scrivanie affiancate l’una all’altra e magicamente animato dal soffio lieve della speranza. E’ la redazione napoletana de L’Unità che, con quella di Paese Sera in piazzetta Matilde Serao 16, raccoglie la “meglio gioventù” del giornalismo cittadino che guarda a sinistra. Parliamo degli anni ‘80 del secolo scorso, quando i giornali avevano un peso specifico di gran lunga superiore all’attuale e, in virtù di questo, erano temuti, eccome, dal potere. In quelle stanze convivono i cronisti locali del quotidiano comunista (Luigi Vicinanza, Vito Faenza, Mario Riccio, Franco Di Mare) e un drappello di corrispondenti della stampa nazionale (Giuseppe D’Avanzo, Fulvio Milone, Patrizia Capua e il sottoscritto). Altri vanno e vengono – a cominciare dagli inviati delle testate nazionali e internazionali più prestigiose – come in un porto nel quale si scambiano idee, notizie, suggestioni. Franco ed io eravamo “compagni di banco” un po’ per caso e un po’ per affinità elettive. Lavoravamo come muli, ridevamo allo spasimo e ci innamoravamo senza sosta. Intorno a noi fluttuava la dolce musica delle macchine da scrivere, un ticchettio convulso e allegro che non ho mai dimenticato. Quel posto grigio e illuminato male era una fucina di sogni, un’alchimia di furori e ingegni che, pur avendo un chiaro orientamento politico, non plasmava le notizie a uso e consumo di un’ideologia. Avremmo lottato contro i diavoli per fare di questo mestiere l’epicentro delle nostre esistenze in una città che faticava a digerire (e fatica tuttora) la libera circolazione delle idee, la prevalenza del merito su quella del cretino, la valenza “pubblica” che l’informazione contiene nel suo dna. Ci siamo riusciti? Mi sembra di sì. Ma fuori da Napoli. Tutti, chi più e chi meno, abbiamo raggiunto posizioni di prestigio nei grandi giornali italiani. Ma fuori da Napoli. Che è stata per noi, e per tanti altri di quella generazione, una matrigna ringhiosa, anaffettiva, sprezzante, un luogo refrattario al pensiero trasversale e addormentato in una quiete inoffensiva. Forse immutabile, dato che qui la convenienza ha radici più solide che altrove.
In questa temperie di sentimenti abbiamo imparato la natura del posto in cui siamo nati e il senso profondo di una professione che, se la ami davvero, ti regala le scarpe per calpestare il suolo e non scivolarci sopra come una bava di sapone. Lo so, di quegli anni lontani rimangono detriti sparsi qua e là. Il giornalismo, alle prese con una crisi devastante innescata dalla rivoluzione digitale, è sempre meno un cane di guardia e sempre più una bestiola accucciata ai piedi del potere. La nostra città sguazza in un oleoso conformismo culturale che, spesso e volentieri, tramortisce ogni scintilla di novità e la politica si è trasformata in un mercato rionale dove si urla per vendere la propria merce. Eppure se riguardo quella foto ingiallita, trovo gli stessi sorrisi di allora sui volti di chi non c’è più (Peppe, Mario, Vito, adesso Franco) e di chi è rimasto (Fulvio, Gigi, Patrizia). Perché se è vero che non abbiamo cambiato il mondo, sappiamo che il mondo non ha cambiato noi. E che, malgrado i mille ostacoli, ci siamo divertiti tanto, ma proprio tanto, nel restare fedeli agli ideali della gioventù. Potrei aggiungere in un altro scatto i visi di Matteo Cosenza, Enrico Fiore, Mariella Cirillo, Eleonora Puntillo, Luigi Mariconda, Luciano Scateni, Lucio Seneca, Luciano Giannini e tanti di quel tempo che navigano ancora controvento o sono salpati verso una costa ignota. Ecco, Franco: non è certo il romanzo che volevamo scrivere insieme per raccontare la Napoli che scorreva dietro le finestre di via Cervantes 55, la storia di speranze randagie riunite in branco dalla fede nel giornalismo, ma la piccola testimonianza che nulla passa invano se la passione resiste. Quando ci siamo visti l’ultima volta eravamo su una terrazza affacciata sul golfo. Mi dicesti: “Questa città puoi amarla soltanto dall’alto o con i piedi nel mare”. Ora sogno che la tua anima venga cullata dalle acque di Posillipo. Con la stessa dolcezza e la stessa galanteria che tu hai regalato ai giorni di chi ha avuto la fortuna d’incontrarti.
Enzo D’Errico
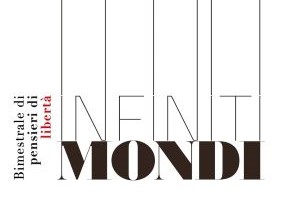



Ricordavo bene questo articolo di Enzo D’Errico, molto bello, e ho pensato che tempi❣️quando andavamo all’Unità per qualsiasi informazione da dare o ricevere c’era semplice qualcuno/a che ti ascoltava: si respirava complicità di campo? Largo? No: Campo con la C maiuscola🏳️🌈🌹