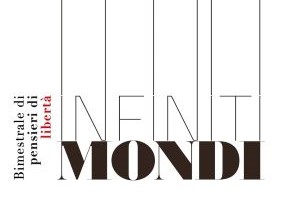Marcello Colasurdo, l’artista, il musicista, il protagonista assoluto della canzone popolare e del lavoro, il compagno ci ha lasciati il 5 luglio. Grande emozione ha suscitato la scomparsa di questa figura straordinaria di militante politico e di intellettuale organico al suo popolo, il mondo del lavoro di Pomigliano d’Arco e di tutto il mondo per davvero. Lo ricorderemo nel prossimo numero di Infinitimondi con la versione integrale di una intervista che gli fece un po’ di anni fa Mimmo Grasso, che ringraziamo per averla voluta rendere disponibile: ne anticipiamo qui una parte.
“[…] La mia era una ragazza madre. Sono cresciuto prima in orfanotrofio e poi in quella famiglia allargata che, a Pomigliano d’Arco, era il cortile di Vico della Pigna. Lì, in quell’abbraccio di mura scauciate, tutto era in comune, anche la fisiologia. Ho vissuto in tribù fino ai 19 anni. Eravamo tutti parenti, non necessariamente di sangue. In quel cerchio chi comandava e gestiva la vita erano le donne, tutte chiamate zie, cummare, in un intreccio un po’ sacrale. Mammane e mammoni. Erano come le leonesse o altri animali che provvedono anche ai cuccioli degli altri. La sera, quando volevo uscire un po’ con i miei amici, mia madre non diceva ritirati presto ma accuogliete ampressa. L’accuogliersi, il raccogliersi, è dei fiori quando si chiudono o quando una mano li raccoglie. In italiano sarebbe forse ritrovati presto, come se l’andare fuori dal cerchio del cortile e dal territorio dominato e protetto dal gruppo significasse poter perdere le coordinate mentali rischiando l’errare, nel doppio significato di sbagliare e di vagare. Un’altra frase che ricordo è: accoglietevi in seno al cortile. Che volevano dire mia madre e le zie? Cos’era quel seno del cortile? Lo dicevano muovendo le mani a cerchio, come radunando foglie, portandole poi alla pancia, dove le mani restavano intrecciate e in riposo. Fuori, in campagna, gli alberi, che in qualche lingua sono di genere femminile, avrebbero voluto forse fare lo stesso con le loro foglie e semi… Lì, alla Pigna – e a volte ho nelle narici, proveniente da chissà dove, l’odore d’incenso che regalano le pigne sul fuoco, lo stesso afrore del turibolo – la morte e la nascita erano come il respiro, nel senso che il cerchio e il seno continuavano il proprio ciclo per nulla interrotto e anzi gemellare con quello della nascita e della morte. Il morto veniva messo nel tavuto, in quella ù oscura e profonda, insieme con il grano, il vino, in comunione con la terra. Certo, si gridava per il dolore ma, anche, si intonavano canti amari come le fronde del limone e il lutto veniva gestito tutti insieme, cantando le gesta del defunto, gesta piccole ma epiche in rapporto al lavoro dei campi. Erano, i morti, gli eroi minimi dei solchi e delle gelate, con un cursus di vita non discrezionale ma previsto e prescritto, come le stagioni. La donna è animale stagionale, soggetto a mutamento. È corpo. La transustanziazione del latte in sangue e l’arcano del latte che dà nutrimento (un corpo che nutre un altro corpo) avevano qualcosa di terribile. Terribile, come si sa, deriva da terra. Il mistero della trasformazione corporale veniva cantato con un ritornello sul soma del defunto: benedico il latte che ti ho dato/ tutto dai miei capezzoli/ con quella bocca muta lo hai succhiato/ prendilo nel giardino (paradiso, cimitero) insieme agli altri (non restare solo).
Fu così che il canto divenne per me qualcosa di pietra, di brecciume, monumentale come chi avrebbe voluto ridare al defunto una voce di marmo, edificare un’icona sonora...”