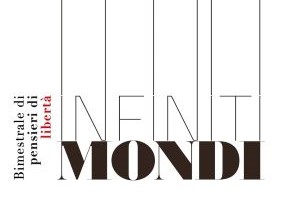Siamo nel pieno di un angoscioso collasso di civiltà, di cui la guerra russo-ucraina è l’aspetto più drammaticamente appariscente e la “crisetta” di casa nostra solo una periferica rappresentazione, caricaturale nella forma ma veritiera nella sostanza. L’Europa rischia di ritornare nei paraggi di dove si trovava nella primavera del 1945. Allora la salvò una coalizione tra l’Occidente liberaldemocratico e l’orso sovietico: quest’ultimo immolò 20 milioni di vite per contribuire a trarla dalla barbarie in cui l’avevano precipitata la follia di Hitler e della sua patetica controfigura di Palazzo Venezia. Seguirono quattro decenni formidabili, in cui l’equilibrio del terrore costituì una straordinaria clausola di garanzia, quasi una polizza assicurativa contro la possibilità di passi indietro. Furono i quattro decenni durante i quali, aprendosi un cuneo tra l’imperialismo americano e la tragica torsione autoritaria del modello sovietico, quella parte della sinistra europea che aveva accettato le regole della competizione elettorale per il potere (senza peraltro mai rinunziare al gusto inebriante dell’utopia) riuscì – talvolta governando da sola, molto più spesso attraverso alleanze con i cattolici e i liberali – a costruire un modello sociale irripetibile. Che non sarà stato il vagheggiato paradiso in terra, ma ha comunque permesso a diversi milioni di donne e di uomini di affrancarsi in toto o in parte dalle miserrime condizioni di vita in cui li avevano trascinati le dittature e la guerra. E furono molti, molti di più, quelli investiti dall’ondata possente e benefica dei diritti di cittadinanza codificati nelle nuove costituzioni democratiche che chiusero in via definitiva l’epoca dei totalitarismi.
Pur tra mille limiti, scelte tattiche e strategiche discutibili, contraddizioni e improvvise mancanze di coraggio, questo processo ha marciato prevalentemente sulle gambe di forze socialiste e democratiche la cui sostanziale (anche quando non dichiarata) neutralità rispetto ai due blocchi che si sono fronteggiati minacciosi per buona parte del dopoguerra è stata la vera “terza via” stabilizzatrice, che ha consentito all’Europa di “costruirsi” in un clima di pace e concordia. Ora, quell’ordine che per tutta la seconda parte del Secolo breve la sinistra si è fatta piacere (anche e soprattutto quando gli andava stretto), accontentandosi di “aggiustarlo” qua e là, conosce il suo momento di massimo declino. A poco più di trent’anni dal crollo del comunismo, assistiamo al fallimento del suo più irriducibile antagonista: il liberalismo, che un secolo fa alzò bandiera bianca di fronte all’avanzata dei totalitarismi liberticidi e oggi è messo fuori combattimento dalla parte più estrema di sé.
Il malinconico tramonto del settantennio liberale si porta con sé l’unico mondo che quattro o cinque generazioni di occidentali hanno conosciuto. Ha scritto di recente Alessandro Colombo nell’introduzione a “Good bye West! La fine della centralità dell’Europa e il futuro della globalizzazione economica” un pamphlet che ripubblica (per i tipi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli editore) un celebre saggio di Antonio Labriola: “Tutto quello che avevamo creduto e su cui avevamo posto la nostra fiducia all’indomani della fine del Novecento – il multilateralismo, le istituzioni internazionali, la globalizzazione, l’egemonia “benigna” degli Stati Uniti; e poi ancora la mancanza di alternative alla democrazia liberale, l’obsolescenza della guerra, l’irreversibilità delle organizzazioni internazionali – insomma tutto il repertorio politico e retorico del Nuovo ordine liberale aveva già cominciato a disgregarsi da almeno quindici anni. Perché, insieme a questo repertorio, era venuta meno anche la condizione storicamente anomala in virtù della quale i vincitori della Guerra fredda avevano potuto convincersi di poter plasmare a proprio piacimento l’ordine internazionale senza doversi più confrontare con altri”.
Di questo default annunciato l’Italia è stata prima laboratorio (con i suoi governicchi tecnici succedutisi nel quindicennio di cui parla Colombo) e, nei 17 mesi di vita dell’esecutivo “dei migliori” trasformato presto in una ridotta dell’alleanza atlantica priva di qualsiasi autonomia politica e strategica (la visita di Draghi al dittatore turco Erdogan che, solo pochi giorni prima, aveva dato il via libera all’ingresso della Finlandia nella Nato ottenendo in cambio l’autorizzazione a continuare il genocidio dei curdi è già diventata una pagina ignobile della storia repubblicana), una delle punte più avanzate. Di fronte a un quadro internazionale che si è andato sempre più complicando col passare dei mesi, e che il governo dimissionario ha irresponsabilmente tagliato con l’accetta, oltretutto violando reiteratamente l’articolo 11 della Costituzione, il “fronte interno” ha assunto caratteristiche sempre più in linea con la tendenza generale e molto simili a quelle che, giusto un secolo fa, prepararono il terreno per la svolta autoritaria dell’uomo di Predappio. Il baricentro della crisi è diventato il Pd, straordinario accrocco di potere e parabola perfetta della mutazione antropologica della sinistra italiana. Un partito spostatosi sempre più verso destra che si è trascinato dietro, dopo averli coinvolti nella sua orgia di potere, quelli che un tempo erano detti “cespugli”, in procinto di diventare elettoralmente dei rami inerti. E che adesso si aggrappa a Draghi, aiutato a scappare dalle sue responsabilità (crisi energetica, inflazione galoppante, emergenza pandemica tornata più forte di prima) con dimissioni che, al di là della drammatizzazione fatta dai media mainstream, fanno nascere il sospetto di una manovra di Palazzo concertata per tentare – attraverso il ricorso affrettato alle urne – di fornire una legittimazione popolare alla democratura “tecnica” in cui siamo stati trascinati da circa un anno e mezzo.
In realtà, la crisi internazionale aveva già disegnato il perimetro del centrosinistra (?) che perderà le Politiche anticipate del prossimo 25 settembre, spianando la strada alla coppia Meloni-Salvini: oltre al Pd, ne faranno parte gli scissionisti dei Cinque Stelle raccoltisi intorno a Di Maio, Mdp-Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva, Azione, l’immarcescibile Bonino, i tre transfughi di Forza Italia, Brunetta, Carfagna e Gelmini: un “campo largo” che somiglia tanto a un camposanto. In questa scombiccherata compagnia costretta a riproporrà al Paese la cosiddetta “Agenda Draghi” in mancanza di una propria visione e orizzonte strategico, entrerà, come ruota di scorta (ma Letta manco la nomina, tanto la ritiene irrilevante), anche la sigla più antica della sinistra italiana che a agosto festeggia il suo 130esimo compleanno, sciaguratamente appaltata a un ristretto circoletto dopolavoristico impegnato solo a garantire ai propri soci qualche strapuntino alla Camera e al Senato, magari in coabitazione con i destrorsi Renzi e Calenda. Un quadro desolante, in cui s’intrecciano grandi tendenze epocali e piccole miserie personali, morali, politiche, culturali. E questo intreccio a sua volta delimita l’area della profonda regressione antropologica in cui siamo immersi. Sicché, a distanza di quasi un secolo, viene spontaneo far risuonare il monito di Rosetta Luxemburg: Socialismo o barbarie, tertium non datur. Socialismo con chi ci sta e, allora come ora, vuole capovolgere lo stato delle cose. In Italia, in Europa, in Occidente, nel mondo.
Massimiliano Amato