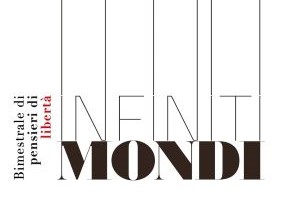LA CULTURA NON SCISSA
di Bruno Arpaia
È stato verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso che Pietro Greco mi chiese se volevo tenere un corso al Master in comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste. Ci conoscevamo già, ma non poi così a fondo. Io gli fui molto grato per aver pensato a me. Però, dopo averlo ringraziato, la mia prima reazione fu: «Ma cosa vuoi che insegni? Sì, è vero, sono uno dei pochi scrittori appassionati di scienza, ma certamente non tanto da poter insegnare qualcosa… No, dai, non me la sento». La sua risposta fu netta, con quel suo modo gentile di sfidarti, di costringerti a essere migliore: «Ma io voglio che tu insegni quello che sai: come si racconta una storia. Perché comunicare la scienza vuol dire saperla trasformare in una storia, ed è importante che i ragazzi sappiano anche di letteratura».
Quella sua determinazione e quella sua apertura, la necessità per lui chiarissima di mescolare scienza e letteratura, mi sorpresero, in una persona che allora per me era soprattutto un bravissimo giornalista scientifico. Ma avrei scoperto ben presto che Pietro era molto, molto di più di un giornalista: era un intellettuale profondo, che, oltre che di scienza, sapeva di storia, di economia, di arte, di politica, era uno studioso a cavallo tra le cosiddette «due culture», un uomo rinascimentale, con in più l’umiltà, l’ironia e l’autoironia di chi è davvero grande.
Ed era soprattutto una persona buona, gentile, generosa, arguta. Pietro non alzava quasi mai la voce, parlava in punta di piedi, era timido e discreto, sembrava che non si infervorasse, che non si entusiasmasse mai per nessuna cosa. Sembrava. Era solamente il suo particolare modo di andare per il mondo, quasi cercando di non mettersi in mostra, di non disturbare; però quello che diceva non mancava quasi mai di accenderti una luce, un guizzo, un’intuizione.
E avrei scoperto ben presto che il suo sguardo a trecentosessanta gradi teneva sempre un occhio fisso sull’arte, sui rapporti, strettissimi, fra arte e scienza.
Grazie a quel suo invito, e poi, negli anni successivi, grazie alla sua generosità, al suo continuo desiderio di condividere e di mettere in relazione le persone che stimava, io ho potuto addentrarmi sempre più nel mondo della scienza, conoscere scienziati, ricercatori, comunicatori, tanto che da allora ho scritto anche due o tre romanzi con al centro la fisica o la crisi climatica. E in quel quarto di secolo di vicinanza e di amicizia Pietro mi ha anche spinto, incitato, insegnato tantissimo. Perché Pietro era anche un maestro, cosa rarissima di questi tempi.
Ma la battaglia che più abbiamo avuto in comune in questi anni, è stata quella contro le cosiddette «due culture», contro la loro separazione, la «schisi» diceva lui, riprendendo un’espressione di Primo Levi. Ci sembrava assurdo che nella nostra società, che paradossalmente viene chiamata società della conoscenza, si possa essere considerati colti se si conoscono Dante, Mozart, Caravaggio o Platone, ma l’ignoranza su Einstein, Heisenberg o Darwin non viene ritenuta rilevante per determinare il nostro grado di cultura.
Già, perché, diceva Pietro, non è soltanto vero che, insieme, le arti e le scienze formano la nostra cultura; è vero anche che possiedono una sostanziale unità, sono una cosa sola. Lo ricordava Primo Levi: «La distinzione tra arte, filosofia, scienza non la conoscevano Empedocle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani di oggi, né i fisici esitanti sull’orlo del conoscibile».
Così, per anni, per corroborare, e per comunicare efficacemente questa idea, abbiamo cercato nella storia, nella letteratura, nell’arte, nei procedimenti creativi degli artisti e degli scienziati gli esempi di come gli occhi con cui guardavano il mondo queste due categorie, apparentemente così distanti, in fondo fossero gli stessi, come per entrambe la conoscenza fosse una passione e un’avventura emozionante. Cercavamo di rendere evidente a chiunque che la vecchia distinzione per cui l’arte cerca la bellezza e la scienza la verità fosse falsa, leggendo Picasso, Paul Klee, Vargas Llosa, Paul Dirac o Jacques Monod.
Io scovavo un passaggio di Poincaré o di João Magueijo, un cosmologo dell’Imperial College di Londra, in cui gli scienziati accostavano i procedimenti che portavano alla scoperta scientifica alla creatività artistica, lui mi incitava a leggere Hadamard o Gerald Holton, oppure mi parlava della strepitosa coincidenza temporale della relatività ristretta einsteiniana e delle Demoiselles d’Avignon di Picasso. Io cercavo di dimostrare che il lavoro artistico ha poco a che fare con l’idea romantica di ispirazione e più con quella di disciplina, come aveva sottolineato Flaubert, e lui mi rispondeva con una citazione di Eduardo Caianiello: «Non esiterei a sostenere che la scienza è fatta di una mescolanza inestricabile di arte, tecnicismi e metodo». Qualunque scrittore degno di questo nome non esiterebbe a sostituire la parola “scienza” con “letteratura”, a dire lo stesso di un suo romanzo. Non contento, Pietro mi spinse anche a scrivere un breve testo teatrale, un dialogo immaginario tra Caianiello e Norbert Wiener.
Ma con Pietro si parlava di tutto: di storia (fenomenale ed enciclopedico uno dei suoi ultimi lavori, La scienza e l’Europa, in cui spaziando in ogni angolo del mondo e del sapere, a partire dagli albori della civiltà, dimostrava come fosse stata la Scienza a far nascere l’idea di Europa), parlavamo di fisica, sua e mia grande passione. Uno dei suoi ultimi libri, Quanti, è, come ha scritto Gianni Battimelli, «l’unica esposizione pensata per un pubblico generalista della storia della meccanica quantistica che copre tutto il periodo che va dagli anni della sua gestazione fino al dibattito dei giorni nostri».
Con Pietro, parlavamo di ambiente e di crisi climatica, anche a partire dai miei romanzi, sui quali aveva scritto cose meravigliose, perché l’amicizia faceva sì che mi sopravvalutasse, e molto, parlavamo di politica e di società (sempre attentissimo non solo alle idee generali, alla coerenza del proprio percorso politico, ma anche all’attualità), parlavamo delle difficoltà, anche economiche, crescenti per chi in questo paese si occupa di cultura.
Forse è da queste ultime difficoltà a cui accennavo che è nato il libro che abbiamo scritto insieme, La cultura si mangia!, in risposta alla famosa frase del ministro Tremonti, per dimostrare, con dati, cifre ed esempi storici, che la cultura (e cioè le attività creative, la ricerca scientifica, la scuola, l’università, considerate come una cosa sola), non è soltanto importante di per sé, ma è fondamentale dal punto di vista economico, e come l’intervento dello Stato sia necessario per cambiare il sistema produttivo del nostro paese ed evitare di proseguire nel declino.
Scrivere un libro a quattro mani con Pietro è stata un’esperienza magnifica. A parte la sua precisione, la puntualità, l’attenzione, la capacità di macinare moli di lavoro e di scrittura impressionanti, Pietro aveva una brillante mente analitica, quasi classificatoria, che contribuiva a fare chiarezza in territori paludosi e complessi; sapeva risalire alle cause profonde, strutturali, dei problemi italiani. Tirava fuori dalle fonti più accreditate dati, cifre, che riusciva a non rendere mai pesanti con la sua scrittura piana, quasi colloquiale, nitida. Ed era sempre attento alla pars costruens, a fornire soluzioni, a indicare strade, vie d’uscita dal buco nero del nostro «sviluppo senza conoscenza», basato su prodotti a bassa e media tecnologia, dal declino in cui il nostro paese si è infilato da parecchi decenni.
Devo dire che anche il mio ultimo romanzo, Il fantasma dei fatti, lo considero scritto a quattro mani con Pietro, tanto che ne è diventato un personaggio. Per gli undici anni che è durata la gestazione di questo libro, è stato lui a insinuarmi il sospetto, e poi a incitarmi, a incoraggiarmi a indagare e a raccontare in un romanzo cosa ci poteva essere dietro gli eventi dei primi anni Sessanta che avevano dato inizio al declino dell’Italia (ancora quel problema): la morte di Enrico Mattei e di Mario Tchou (il direttore del laboratorio elettronico dell’Olivetti), le accuse e le condanne a Felice Ippolito e Domenico Marotta. Diceva che un romanzo, lavorando con l’immaginario, poteva arrivare là dove la storia e il giornalismo non potevano arrivare e continuava a spronarmi soprattutto nei miei momenti di spaesamento di fronte a tutto quel materiale documentale, alle ipotesi che non tornavano…
Nel suo ultimo anno di vita, Pietro ha pubblicato moltissimo, quasi come se avesse una terribile premonizione. E tra i suoi ultimi libri c’è Homo. Arte e scienza, la sintesi dei tanti anni dedicati a parlare, raccontare e dimostrare quanto arte e scienza siano intrinsecamente collegate e parte della stessa cultura, quella umana. Ogni tentativo di divisione di queste «due anime» per lui era innaturale, forzato, se non addirittura strumentale. Homo è la sintesi e il manifesto di tutta la sua ricca attività da comunicatore della scienza. In quattrocento pagine Pietro Greco ripercorre la storia dell’umanità alla luce del rapporto tra arte e scienza, ma anche tra filosofia, comunicazione e politica, dai neanderthal ai Greci e ai Romani, dal Medioevo al Rinascimento, e poi all’Illuminismo, al Romanticismo fino alla modernità, passando per Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Leon Battista Alberti, Dante, Leopardi, Calvino, Primo Levi o Schönberg. Lo ha fatto, come al solito, alla sua maniera: con una scrittura avvolgente, discorsiva, chiara (perché aveva ben chiare in testa le sue idee), con un piglio, più che da saggista, da vero narratore e con una competenza strabiliante. Se doveva parlare di Vincenzio Galilei, del figlio Galileo e dei loro esperimenti musicali, studiava e sapeva cose di musica e di armonia che neanche i diplomati in composizione al Conservatorio… In quel libro ha dimostrato che la scienza è stata ed è fonte di ispirazione per l’arte, e l’arte è stata ed è fonte di ispirazione per la scienza. Ha ripetuto e corroborato l’affermazione di Italo Calvino secondo il quale la vocazione profonda della migliore cultura italiana (e non solo) consiste nel realizzare un ménage à trois fra scienza, filosofia e arte. E nel capitolo finale, Il volo di Mercurio, ha scritto un vero e proprio manifesto – anche politico – sulla cittadinanza scientifica e sulla società della conoscenza, spingendosi a un’affermazione che potrebbe sembrare azzardata e paradossale, ma che lui sostanziava con saldi precedenti storici e teorici: anche i comunicatori della scienza devono sentirsi artisti, le loro storie oltre a narrare devono commuovere. «In altri termini» scriveva, «in una storia scientifica ragione ed emozione, arte e scienza devono fondersi». Non ci sarà mai più qualcuno che ci indicherà con tanta chiarezza e profondità l’unità tra le due culture, la strada da battere in una società che sempre più ha bisogno di cittadinanza scientifica e di democrazia della conoscenza. Non ci sarà mai più qualcuno come Pietro Greco. Non avrò mai più un amico come Pietro Greco.
*L’immagine in evidenza di Bruno Arpaia è tratta dalla sua pagina Facebook