LETTERATURA E ALTRE STORIE a cura di Carlangelo Mauro
Si è tenuto a Castello di Cisterna, il 22 ottobre scorso, un incontro curato da chi scrive su “S. Quasimodo: etica e poesia” (in collaborazione con l’Ufficio Scuola Diocesi di Nola e il Liceo “Medi” di Cicciano) nell’ambito del Premio letterario “Castrum Cisternae” sul tema “La cultura ci salverà”. Il premio è organizzato dalla Pro Loco, presieduta da Fiorella Chirollo, e coordinato da Ferdinando Calabrese. Sono intervenuti all’incontro su Quasimodo, con gli organizzatori, il sindaco Aniello Sepe, il dirigente scolastico del “Medi” Anna Iossa, il responsabile dell’Ufficio Scuola Don Virgilio Marone, il presidente del Parco Letterario Quasimodo di Roccalumera (ME) Carlo Mastroeni, il critico letterario Gerardo Santella. Protagonisti sei studentesse e due studenti del Liceo Medi che hanno letto e commentato, in modo non tecnico, testi di Quasimodo, rivolgendosi anche direttamente al poeta…
“Salvatore Quasimodo per Martin Luther King”
[L’ultimo discorso del poeta pronunciato al Circolo di Via de Amicis l’11 Aprile 1968]
Commento di VINCENZO DELLA PIETRA, classe V sez. B indirizzo tecnologico

L’assassinio di Martin Luther King appare a Quasimodo come un ulteriore «attentato alla convivenza dei popoli» che gli sembra fragile, perché l’idea di «fratellanza», ieri come oggi, risulta condizionata da spinte utilitaristiche e mire eversive che ne impediscono la vera realizzazione. L’umanità è sospesa tra l’essere e il dover essere e progredisce lentamente perché è condizionata da strutture governative soverchianti e da gruppi organizzati che si servono della violenza per imporre il predominio. Quasimodo, dinanzi ad un atto sovversivo e pregnante, come la morte di Luther King, portavoce della tutela dei diritti dei neri americani, nel suo discorso per commemorare la morte del predicatore americano afferma il valore della pace come unica forza aggregante, capace di demistificare il valore dell’odio razziale che da sempre ne impedisce la piena realizzazione. Pace e odio vivono lo stesso rapporto antitetico, per rifarmi all’idealismo, che necessita, per risolversi, di un processo spirituale teso alla realizzazione del massimo concetto di Umanità.
Tale percorso di uscita dalla barbarie è caratterizzato soprattutto da momenti di tensione, da sforzi emotivi, ma l’uomo deve necessariamente arrivare a delegittimare le motivazioni «finanziarie» della disuguaglianza, per arrivare all’idea che tutti abbiano diritto a tutto a prescindere dalle dinamiche socioculturali e soprattutto razziali. Il discorso del poeta-Uomo era ed è proiettato verso il futuro; egli immagina un mondo nel quale i paesi in via di sviluppo partecipino attivamente alle novità della scienza, della tecnica e della cultura per arrivare ad una parità con gli antichi detentori del potere. Le parole di Quasimodo si nutrono delle vicende storiche che hanno condizionato un’epoca caratterizzata dalle aspirazioni di gruppi elitari che alla tolleranza e al bene comune hanno anteposto l’ideologia del dominio, secondo la quale la razza ariana era destinata a dominare il mondo. Persino in America, terra di libertà, indipendenza, uguaglianza, caratterizzata dalla voglia di garantire la piena realizzazione del sogno americano ‒ “la ricerca della felicità” ‒ la brama del potere ha offuscato la libertà mediante il controllo dell’economia e del libero pensiero, ha scatenato il razzismo nei confronti dei neri, il quale nasce, secondo Quasimodo, dal «timore» infondato che «chi possiede qualcosa» si veda «derubato da altri uomini…».
I neri, considerati merce di scambio, «non dovevano avanzare richieste ma dovevano essere contenti di ottenere pane e giaciglio»; il razzismo è quindi, dice Quasimodo, «una corrente di odio, di paura, il seme della viltà e dell’isterismo che sfuggono alla volontà e all’intelligenza». In merito, Freud riconosce un’angoscia, che lui chiama “nevrotica”, che nasce dalla percezione di un pericolo inconscio che si proietta all’esterno.
Martin Luther King, per salvaguardare i diritti dei neri, vedeva nell’amore «il solo rimedio alla paura», quindi per affermare il valore dei diritti umani bisogna aver chiaro che questi sono il frutto di una grande conquista da parte dell’”uomo sociale”, come afferma il biologo francese Jean Hamburger, che prevale sull’”uomo biologico”, teso alla perenne realizzazione dei suoi impulsi primordiali.
Le parole di Quasimodo sono di estrema attualità, in quanto il poeta aveva capito che i fattori economici sono alla base dell’affermazione della volontà di potenza di gruppi ristretti che aspirano al dominio. In effetti egli, nel cogliere il valore dell’azione politico-sociale di Martin Luther King, aspira alla realizzazione di una pace duratura caratterizzata dalla vittoria sociale sull’uomo biologico. Quasimodo anela al radicamento nell’ambito della società del concetto, espresso da Hannah Arendt, del “sensus communis”, funzionale a far sì che ogni individuo riconosca sé stesso come portatore di pace e garante dei diritti dell’altro, con il quale condividere le sovrastrutture sociali in nome di un egualitarismo spirituale di matrice cristiana. Ideale che, negli ultimi tempi, in una società condizionata dalla globalizzazione, attuata dai potenti che hanno paura di perdere “la roba”, sembra essersi arenato in nome del particolarismo sociale e della secolarizzazione.
Il cammino verso l’egualitarismo sociale è lungo perché i diritti umani si realizzano assai lentamente, con il concorso di migliaia di persone; si tratta di un processo non lineare spezzato continuamente da ricadute e imbarbarimenti. Come Nelson Mandela, che ha lottato per i diritti dei neri Sud-Africani, ha scritto nella sua autobiografia: “Dopo aver scalato una grande collina, ho trovato che ci sono ancora molte più colline da scalare”. Pertanto, tutti noi abbiamo il dovere morale di fare in modo che la pace e l’uguaglianza possano divenire valore assoluti.
***
Poesie lette e commentate dagli studenti:
SOLITUDINI
(S. Quasimodo, da “Acque e terre”, 1930)
Una sera: nebbia, vento,
mi pensai solo: io e il buio.
Né donne; e quella
che sola poteva donarmi
senza prendere che altro silenzio,
era già senza viso
come ogni cosa ch’è morta
e non si può ricomporre.
Lontana la casa, ogni casa
che ha lumi di veglia
e spole che picchiano all’alba
quadrelli di rozzi tinelli.
Da allora
ascolto canzoni di ultima volta.
Qualcuno è tornato, è partito distratto
lasciandomi occhi di bimbi stranieri,
alberi morti su prode di strade
che non m’è dato d’amare.
Ognuno sta solo sul cuore della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
GIOVANNI VETRANO, classe V sez. A Linguistico

“Solitudini” racconta in versi un allontanamento da casa dell’io lirico ed è ispirata a vicende autobiografiche. Nel 1920 Quasimodo partì per Roma abbandonando la famiglia, alla ricerca di una sua autonomia, rincorrendo il suo sogno di diventare un letterato. Nella prima parte c’è la tristezza di questa fuga: «Lontana la casa, ogni casa / che ha lumi di veglia». Nella conclusione, vale a dire i tre versi diventati celebri pubblicati come poesia a parte nell’antologia “Ed è subito sera” (1942), il poeta medita sul fatto che ognuno di noi crede di essere al centro dell’universo, ma in realtà viviamo tutti in una condizione di solitudine. Tre soli versi per esprimere i concetti chiave dell’esistenza e della condizione di noi uomini: la nostra situazione di solitudine, la nostra lotta per raggiungere la felicità fugace, il nostro arrenderci alla morte.
«Ognuno sta solo sul cuor della terra», poiché tutti noi uomini siamo tragicamente abbandonati a noi stessi e non riconosciamo la nostra limitatezza rispetto alla grandezza della Madre terra. E pur vivendo in mezzo agli altri ci sentiremo sempre soli a causa dell’incapacità, soprattutto oggi con il predominio della virtualità, di stabilire rapporti umani autentici e duraturi. Tuttavia, pur provando questo stato di abbandono, siamo pungolati dalle illusioni, da piaceri che assaporiamo per un attimo come «un raggio di sole», ma che leopardianamente nascono dal dolore. Siamo sempre alla ricerca di una felicità spesso apparente e quindi, allo stesso tempo, questo raggio ci trafigge come un dardo, facendoci soffrire. E intanto il tempo scorre, alla luce del giorno succede rapidamente l’oscurità notturna e per la nostra vita giunge la morte: “Ed è subito sera”, conclusione che richiama il celebre sonetto “Alla sera” del Foscolo.
***
SENZA MEMORIA DI MORTE
(Da “Ed è subito sera”, 1942; nel libro originario dove era contenuta, “Oboe sommerso”, del 1932, la poesia si intitolava: “Immortalità”)
Primavera solleva alberi e fiumi;
la voce fonda non odo,
in te perduto, amata.
Senza memoria di morte,
nella carne congiunti,
il rombo d’ultimo giorno
ci desta adolescenti.
Nessuno ci ascolta;
il lieve respiro del sangue!
Fatta ramo
fiorisce sul tuo fianco
la mia mano.
Da piante pietre acque,
nascono gli animali
al soffio dell’aria.
MICHELA LUONGO, classe V sez. A Linguistico

“Immortalità”: è questa la condizione che si manifesta e si rivela in te, Salvatore, durante l’atto d’amore?
Questo sentimento, che tanto privilegi, non si riduce solo ad un puro e mero evento fisico, ma ad esso attribuisci un valore che si proietta in una visione fortemente spirituale: l’amore ti ha permesso di congedarti dallo scrosciante e perpetuo rumore della morte rendendola vinta, e di far nascere in te un senso di eternità, rimedio al tuo affanno interiore.
In esso ti dissolvi e ti disperdi con la tua amata, e per te tutto si annulla, tutto cessa di esistere: il rombo notturno della tempesta, l’attesa del giorno del giudizio, la memoria del sonno eterno e dell’arrivo di un futuro imminente con il suo carico di mali.
Per te non sono più un incessante tormento, né più un motivo di angoscia al quale piegarsi.
L’amore si traduce in rinascita che ti redime dalla schiavitù della tua costante preoccupazione: per te si identifica nell’unico strumento di difesa dal pensiero di un destino già stabilito, che trova il suo conforto nel respiro soave e delicato della tua amata.
La vostra unione è sacra: vi fonde in un solo corpo, in una sola carne, convertendo quella semplice e pura esperienza d’amore in un ‘hieròs gàmos’, evocando una dimensione divina che ti consente di superare la morte in uno spazio senza tempo e di risvegliare in te l’illusione di un tempo infinito.
Ti elevi, paragonandoti a Dio, durante il rapporto d’amore condiviso con la tua amata che è e dà vita, proprio come quel “soffio dell’aria”, il soffio vitale che anima l’universo e l’uomo, che pervade tutto il mondo e dalla cui energica forza spirituale che perpetua l’esistenza tutto ha avuto origine: «Da piante pietre acque, / nascono gli animali / al soffio dell’aria».
***
THÀNATOS ATHÀNATOS
(da “La vita non è sogno”, 1948)
E dovremo dunque negarti, Dio
dei tumori, Dio del fiore vivo,
e cominciare con un no all’oscura
pietra «io sono» e consentire alla morte
e su ogni tomba scrivere la sola
nostra certezza:«thànatos athànatos»?
Senza un nome che ricordi i sogni
le lacrime i furori di quest’uomo
sconfitto da domande ancora aperte?
Il nostro dialogo muta; diventa
Ora possibile l’assurdo. Là
Oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi
vigila la potenza delle foglie,
vero è il fiume che preme sulle rive.
La vita non è sogno. Vero l’uomo
e il suo pianto geloso del silenzio.
Dio del silenzio, apri la solitudine.
SARA CAVEZZA, classe V sez.A Linguistico

“Thànatos Athànatos”, è questo il titolo della composizione appena letta che viene così tradotto: ‘Morte immortale’, il che al principio potrebbe apparirci semplicemente come l’accostamento di due parole di origine greca contrastanti tra di loro. In realtà, il messaggio che Quasimodo vuole far comprendere a tutti noi è ben più profondo: la morte è una certezza inconfutabile della nostra esistenza, non può essere messa in dubbio da alcuna argomentazione; ma il vocabolo antitetico ‘athànatos’ implica la condizione opposta, ossia quella di immortalità.
So per certo che nella mente di ognuno di voi una domanda sorge spontanea: è possibile trovare un modo per sottrarsi alla propria scomparsa e poter vivere eternamente? Dare una risposta si mostra come un’impresa complessa e siamo portati di conseguenza ad affermare che questo presupposto sia inverosimile e a dichiarare come imperitura solo la fine della vita umana. In questo caso, per il nostro autore, stiamo compiendo un grave errore: la lunga domanda retorica della prima parte (“E dovremo dunque negarti Dio….), già ci dà la risposta: accettando la morte immortale otterremo solamente la disfatta del nostro essere uomini e andremo a negare implicitamente anche la presenza di Dio. Il quesito che ci siamo posti può ricevere una risposta dalla fede che è l’unica arma che ci consente di avere fiducia nell’eternità della nostra anima o saremo «sconfitti da domande ancora aperte», quelle domande che ci riconducono irrimediabilmente a dubbi ed incertezze, di cui anche il nostro poeta si fa portavoce nei suoi versi. Durante la lettura della poesia ci sembra che pensieri abissali, domande profonde che ognuno di noi si pone (‘Chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo? quale è il senso della nostra esistenza?’) emergano per un attimo e vengano portate a galla da Quasimodo, il quale ci ricorda che «la vita non è sogno». Vale a dire: in questa fuga continua di giorni, non dobbiamo lasciarci trasportare dall’idea che tutto sia un qualcosa di passeggero ed inconsistente, perché la nostra esistenza è reale, non è sogno o illusione, e come tale si manifesta a tutti con le sue emozioni, sofferenze e soprattutto misteri.
Il nostro autore si pone su un piano di dialogo con il divino manifestando la necessità di confronto con una dimensione assurda e reale nello stesso tempo (Blaise Pascal: «L’ultimo passo della ragione è il riconoscere che vi sono un’infinità di cose che la superano…») e soprattutto la necessità di un conforto. Gli enigmi che attanagliano il genere umano, sin dall’antichità, per Quasimodo non possono essere risolti solo con l’ausilio della ragione. Invocare Dio ci appare allora come un bisogno che sgorga dalla profondità del nostro essere più profondo che come un fiume in piena prova ad abbattere la solitudine umana e a placare le nostre inquietudini ed affanni, non ancora rimarginati: «Dio del silenzio apri la solitudine». La religiosità si rivela quindi come uno spiraglio di luce al quale aggrapparsi, senza l’esigenza di segnali che la dimostrino (il “Dio nascosto” delle Sacre Scritture) e che spalanca, dopo una lunga ricerca, le porte di un nuovo cammino, fatto di salvezza e speranza.
***
ALLE FRONDE DEI SALICI
(da “Giorno dopo giorno”, 1947)
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
GRAZIAMARIA DATTOLO, classe V sez. B Linguistico

Il poeta Salvatore Quasimodo scrive la poesia “Alle fronde dei Salici” durante il periodo dell’oppressione nazista, svolgendo una profonda e dolorosa riflessione sul significato e il ruolo della poesia che è stata priva di parole dinanzi all’orrore provocato dalla Seconda Guerra Mondiale.
La poesia, che apre la raccolta “Giorno dopo giorno”, ci presenta come tema principale il periodo della guerra civile e della resistenza ai fascisti e ai tedeschi. Il tema è fortemente evidenziato dal verso: «con il piede straniero sopra il cuore» ‒ titolo anche di una raccolta del 1946 confluita in quella successiva ‒ con cui il poeta si riferisce agli invasori che “calpestano” i sentimenti più profondi degli italiani togliendo loro la libertà.
Vi è un importante rapporto tra i versi di questa poesia e un passo biblico, il Salmo 137, in cui gli ebrei deportati a Babilonia si rifiutano di cantare i propri salmi lontano dalla propria casa e appendono le cetre ai salici piangenti in segno di lutto. Allo stesso modo, quindi, anche per i poeti è impossibile dedicarsi al canto, alla poesia durante la guerra, di fronte all’oppressione tedesca e al dolore straziante che porta con sé. Scorrono davanti agli occhi i morti tristemente abbandonati nelle piazze o sui prati pieni di neve, si sentono il pianto dei bambini paragonati ad agnelli innocenti spaventati dai bombardamenti aerei, “l’urlo nero”, disperato di una madre che cerca suo figlio ormai morto. È difficile per un poeta sottrarsi al canto, ma davanti agli orrori del nazismo non ci sono versi per esprimere la propria paura, la rabbia e il proprio sconforto, tanto che, come gli ebrei, davanti a tutto questo dolore si preferisce il rimbombante silenzio. E allora i fogli vengono metaforicamente appesi ai rami degli alberi (come voto), chiedendo a Dio la fine dell’oppressione nazista. In quegli anni occorre ricordare che il filosofo Adorno affermò che dopo Auschiwtz è impossibile scrivere poesie o è «un atto di barbarie» farlo.
Quelle descritte nella poesia sono immagini molto forti, reali, che ci aiutano a immaginare perfettamente le scene strazianti avvenute durante l’occupazione nazista, a Milano come altrove; quasi possiamo udire il grido disumano della madre che piange suo figlio ormai morto (c’è un riferimento alla Madonna e a Gesù Cristo nella figura del partigiano crocifisso «sul palo del telegrafo»).
Il senso del testo a me sembra anticipato già nel verso iniziale: «e come potevamo noi cantare», con la prima persona plurale, ‘noi’, che dice anche il bisogno di solidarietà e fratellanza del popolo, la necessità della condivisione del dolore per alleviare il peso di ognuno. Il piano comune, che porterà l’Italia divisa dalla guerra civile all’unità con il crollo della Repubblica Sociale Italiana di Salò (nazi-fascista), sembra essere, quando Quasimodo scrive, solo uno spiraglio di luce nell’immenso buio. Troverà concreta applicazione nella nostra Costituzione, nella Repubblica antifascista nata dopo il conflitto, il nuovo patto collettivo da cui ripartire.
***
UOMO DEL MIO TEMPO
(da Giorno dopo giorno, 1947)
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
GUERRIERO AURORA, classe V sez. B Linguistico

“Uomo del mio tempo” chiude significativamente la raccolta “Giorno dopo giorno”. La poesia, come altri componimenti divenuti celebri, nasce dagli orrori della Seconda Guerra mondiale. Il tema centrale della poesia è infatti la guerra, una costante della storia: «Hai ucciso ancora, / come sempre, come uccisero i padri». A questo tema si ricollega quello di un progresso solo esteriore, tecnologico e scientifico («La scienza esatta persuasa allo sterminio») ma dentro l’uomo è ancora dominato da sentimenti e istinti brutali, dalle passioni negative, dall’egoismo, dalla rabbia, dall’odio. Sono queste, al di là delle parole e delle ideologie che vogliono coprirle, alla base dei gesti, del ‘fare’ dell’uomo, che, pur essendo cosciente delle conseguenze disastrose che una guerra apporta, non ha mai smesso di farla. La natura umana è quindi nel profondo rimasta uguale a quella dell’uomo «della pietra e della fionda’», producendo effetti ben peggiori (un’altra celebre poesia di Quasimodo è dedicata ad “Auschwitz”…). Il “progresso” ha permesso di fare delle guerre sempre più devastanti, come i due conflitti mondiali, la differenza è che dalla «fionda» si è passati al «carro di fuoco», ai carri armati o ai bombardieri che seminano la morte, in ultimo alla invenzione della bomba atomica (la poesia fu scritta nel 1945, dopo lo scoppio della bomba su Hiroshima). L’«uomo del mio tempo», afferma Quasimodo, ha perso «Cristo» come anche ogni tipo di rispetto laico per i suoi fratelli, ha perso i valori della solidarietà e della fratellanza. Quasimodo risale alle origini, ai tempi biblici di Caino e Abele, quando il fratello tradì l’altro fratello e lo uccise. Come allora, anche oggi l’uomo tradisce e uccide l’altro uomo, ripetendo la risposta di Caino all’interrogativo di Dio: «sono forse io il custode di mio fratello?».
Nella parte finale del componimento l’autore rivolge un appello ai giovani a dimenticare «i padri», affinché non siano condizionati dalle azioni che essi hanno compiuto: dopo la vergogna di Hiroshima e di Auschwitz, giacciono giustamente dimenticati nelle tombe mentre gli avvoltoi rodono il loro cuore.
L’obiettivo che, in conclusione, Quasimodo si propone in “Uomo del mio tempo” è quello di immaginare, anzi di reclamare, una società nuova che cammini sulle gambe di noi giovani, un futuro di pace e fratellanza per il destino dell’umanità.
A tutt’oggi vi sono molti conflitti attivi nel mondo poiché contano principalmente nella società contemporanea pseudovalori come la ricchezza, il potere, l’avidità e il dominio. Il 20% per cento dell’umanità, all’ingrosso, detiene l’80% delle risorse. Diffondere la cultura della pace e costruire un modello di sviluppo meno squilibrato e meno predatorio, verso gli altri e la stessa natura, è oggi la prosecuzione, in concreto, del discorso poetico di Quasimodo.
***
VARVÀRA ALEXANDROVNA
(da “Dare e avere”, 1966).
Un ramo arido di betulle batte
con dentro il verde su una finestra a vortice
di Mosca. Di notte la Siberia stacca il suo vento
lucente sul vetro di schiuma, una trama
di corde astratte nella mente. Sono malato:
sono io che posso morire da un minuto all’altro;
proprio io, Varvàra Alexandrovna, che giri
per le stanze del Botkin con le scarpette di feltro
e gli occhi frettolosi, infermiera della sorte.
Non ho paura della morte
come non ho avuto timore della vita.
O penso che sia un altro qui disteso.
Forse se non ricordo amore, pietà, la terra
che sgretola la natura inseparabile, il livido
suono della solitudine, posso cadere dalla vita.
Scotta la tua mano notturna, Varvàra
Alexandrovna; sono le dita di mia madre
che stringono per lasciare lunga pace
sotto la violenza. Sei la Russia umana
del tempo di Tolstoj o di Majakovschij,
sei la Russia, non un paesaggio di neve
riflesso in uno specchio d’ospedale
sei una moltitudine di mani che cercano altre mani
NIKA NAPPI, classe V sez. A Linguistico

La poesia “Varvara Alexandrovna” è piena di tinte crepuscolari, di sentimenti mesti, malinconici e a tratti nostalgici di una vitalità che si avverte prossima alla fine. «Un ramo arido di betulla» è la metafora con cui Quasimodo apre la poesia, paragonandosi a questo ramo secco d’inverno. Alla fine del primo verso, però, il poeta afferma che questo ramo «batte / con dentro il verde», quindi dentro vi scorre ancora la linfa vitale. A mio avviso, i pensieri e le riflessioni espresse confermano che anche nei momenti più drammatici pulsa forte l’energia fondamentale della vita, a cui ognuno di noi è legato come bene primario. Successivamente, il poeta scrive che il ghiaccio che batte sul vetro è come una «trama di corde astratte alla mente», ciò significa che quei disegni sul vetro gli evocano alla mente immagini legate al male di cui sta soffrendo. Subito dopo questo tratto, si possono avvertire i sentimenti contrastanti in cui si dibatte il poeta che, anche nei momenti più atroci, si aggrappa all’esistenza più vicina come se volesse risucchiarle la linfa, in questo caso alla dolce e materna infermiera Varvara Alexandrovna.
Ancora altri sentimenti di fragilità e consolazione sono significativi, in controluce, ovvero quando Quasimodo dichiara che rischia di morire ma senza paura. Poi afferma che potrebbe sembrare più facile allontanarsi dalla vita dimenticando tutto ciò che la vita porta con sé, come l’«amore», la «pietà…» Proprio a questo punto si scopre la comune debolezza umana che ricerca gli affetti, chiede la solidarietà che sola può aiutare a scontare un momento così buio. Dice il poeta: «scotta la tua mano notturna», riferendosi all’infermiera che lo assiste come una madre meritandosi la dedica di questa poesia.
Infine, per distogliere le sue paure, l’io lirico si allontana con lo sguardo dalla stanza d’ospedale, medita sui grandi modelli della cultura russa, come per salvarsi dai tormentosi pensieri sulla possibile fine della vita. A tal proposito, menziona due grandi autori russi, un poeta, Majakovskij, un narratore, Tolstoi, che come tutti gli altri grandi sono cari all’umanità.
È questo concetto di umanità che mi ispira una riflessione che tengo molto a cuore: l’umanità è la radice dell’anima del mondo, e questa poesia è un invito a vivere con sapienza e accettazione la nostra condizione esistenziale su cui incombe la morte. I sentimenti del poeta ci sollecitano a poter riconoscere senza drammi il nascere e il tramontare di ogni esistenza come ciclo naturale di vita. Quasimodo mi ha trasmesso con questi versi una lezione di vita; a me preme poter imparare a vivere in armonia, come lui ci dice, anche nel dolore…
Infine, ma non meno importante, la considerazione che se la cultura davvero potrà salvarci, per richiamarmi al tema del Premio “Castrum Cisternae” di quest’anno, è necessario sottolineare che i forti sentimenti che questo testo ci comunica accendono il buio e regalano speranza: richiamano gli stessi sentimenti di coraggio, di resistenza e mai di rassegnazione anche di fronte a un evento così tragico come la morte o la possibilità di essa. Quasimodo riesce ad infondere un significato di speranza attraverso l’esperienza, sulla sua pelle, in un momento decisivo, del valore della solidarietà. Varvàra diventa allora un simbolo universale: «Sei una moltitudine di mani che cercano altre mani», conclude il poeta. Penso siano gli stessi temi, per venire a tempi più vicini, del film “La vita è bella” di Roberto Benigni che ha vinto tre premi Oscar. Chissà se Benigni ha letto questa poesia di Quasimodo e ne abbia potuto prendere ispirazione… Non so né posso dare una risposta, posso solo affermare, però, che nella cultura, a partire da un fondo comune, tutto si trasforma per scrivere la storia nei nostri cuori.
***
Una dedica in versi di AURORA PELUSO, classe V sez. B Linguistico

A TE, QUASIMODO
A te, Quasimodo, padre ed intellettuale,
poeta e traduttore, sicuramente non banale.
Tu che volevi solo l’amore della tua città natale,
e quello della Sicilia, così lontana ma fatale;
come quando nella “Terra impareggiabile”,
ci hai fatto commuovere evocando tuo padre.
Ma non hai fatto solo questo:
grazie a te comprendo la natura del dolore ,
con i tuoi discorsi impegnati
che ritroviamo in “Alle fronde dei salici”.
“Che tristezza il mio cuore di carne!”,
ecco le prime parole che esprimono il tuo dolore.
Tu che hai espresso una tale passione,
non solo in privato, ma rendendoci partecipi
come in “Senza memoria di morte”,
in quel biblico “nella carne congiunti”,
oppure nel verso “in te perduto, amata”,
aprendo gli occhi alla forza dell’amore,
rendendomi abbagliata.
Ma ciò di cui più faccio tesoro
è come ci incitasti ad aiutare il prossimo.
E mi immedesimo in quei versi e assaporo:
“sei una moltitudine di mani che cercano altre mani”,
ecco la solidarietà rappresentata in un unico capolavoro.
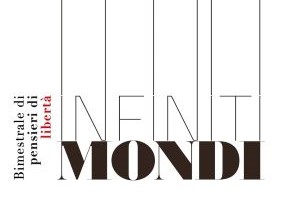
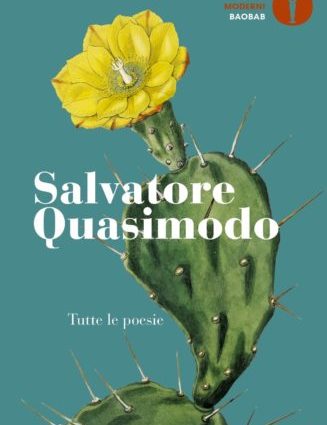


Un grande applauso a questo lavoro di incisivo interesse, accurato e certamente importante nel trasmettere bellezza di singolare qualità.
Lasciatemi lanciare un grande abbraccio a studenti/esse e docenti.