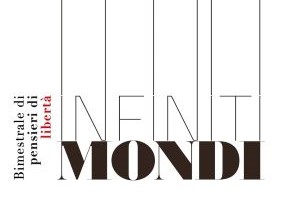La parola Shari’a è entrata da qualche tempo nel nostro vocabolario, divenendo un termine di uso comune, inflazionato, e del quale si abusa. È enorme la distanza tra la vastità concettuale a cui fa riferimento questa parola in lingua araba e la sua disinvolta circoscrizione ad ambiti o a significati ristretti e superficiali, che non aiutano il grande pubblico a comprenderla.
Sulla Shari’a è complicato scrivere qualcosa di sensato e allo stesso tempo renderlo con linguaggio giornalistico, universalmente accessibile; è complicato semplificare in buona fede senza sacrificare le diverse complessità che il termine implica. Per questo c’è un enorme spazio per le banalizzazioni.
Analogamente a quanto accade col dibattito sull’Islam, la tendenza a fuorviare il pubblico sul significato della nozione di shari’a, strumentalizzandola a fini politici, è una prerogativa tanto degli islamofobi quanto dei fondamentalisti islamici, i cui discorsi sono a volte sovrapponibili. È quindi utile fare un po’ di ordine, e cercare di capire cosa significa Shari’a.
1- Cos’è la Shari’a
Anzitutto, la Shari’a non è un corpus di leggi di diritto positivo (non esiste un singolo documento pubblicato col nome di “Shari’a”), non è un testo codificato e sancito in un preciso momento storico, come si lascia intendere di solito, bensì un universo di riferimenti etici, comportamentali e consuetudinari utili a plasmare la condotta dei musulmani. Più che un elenco di leggi speculare al codice penale e civile di un Paese si tratta di una galassia di principi a cui i fedeli musulmani fanno riferimento per la condotta personale, e i giuristi musulmani per elaborare leggi e disposizioni nei paesi in cui sono deputati a farlo.
Questi giuristi sono i fuqawa (plurale di faqih), cioè gli esperti di Fiqh (“comprensione profonda”, termine che designa quindi lo sforzo intellettuale per interpretare la Shari’a, “estraendo” da essa delle norme). Il Fiqh può quindi essere reso con “giurisprudenza islamica”, ed è forse il termine più opportuno da usare quando si allude invece alla Shari’a, che ha una dimensione soprattutto astratta, idealistica, di indirizzo.
Shari’a significa letteralmente “strada battuta verso l’acqua, sentiero”, e come tutti i sentieri può in larga parte essere “sconosciuto agli uomini”, specie quelli privi di adeguati studi teologici. È significativo che un buon numero di musulmani dirà di non essere contrario alla Shari’a, di considerarla sacra, ma allo stesso tempo buona parte di essi vi dirà di essere contrario a cose come la lapidazione, la fustigazione, l’amputazione eccetera, che sappiamo essere quantomeno correlate alla Shari’a. Pregare, astenersi dall’alcol o dalla carne maiale, digiunare, versare l’elemosina, compiere buone azioni, andare in pellegrinaggio: si inseriscono a tutti gli effetti nella “Shari’a”, ed è per questo che un musulmano è restio a “prenderne le distanze”.
Così come nel discorso giornalistico la parola Jihad (sforzo) ha finito col designare la nozione di “guerra santa”, laddove in realtà per il musulmano medio Jihad coincide col concetto personale di “grande Jihad”, cioè “impegno a comportarsi da buon musulmano” nella vita quotidiana (l’adempimento ai cinque pilastri della fede, il resistere alle tentazioni e così via), e solo in secondo luogo col concetto di “piccolo jihad”, cioè di “guerra per difendersi dagli aggressori”, la parola Shari’a ha finito per identificare, nella percezione comune l’applicazione di pene corporali e pena di morte.

2- Il diritto islamico e le interpretazioni
Quando i giornali italiani parlano di “Shari’a” sovrapponendola all’applicazione delle punizioni corporali, alle cosiddette pene hudud (plurale di hadd, “limite”), non fanno altro che il gioco degli stessi letteralisti, degli “integralisti”, un po’ come gli islamofobi perpetuano la retorica propria dei jihadisti, insistendo come loro sulla impossibilità di interpretare un testo storicamente determinato: atteggiamento che finisce per svilirne i messaggi profondi, i principi che possono prescindere dal contesto storico, in favore di un superficiale dogmatismo e di un rozzo legalismo. I salafiti moderni (e gli islamofobi allo stesso modo), conosciuti per il loro approccio “letteralista” ai Testi sacri, sono anzitutto pigri dal punto di vista intellettuale, e per questo finiscono per applicare un testo astratto a una realtà astratta, voltando le spalle alle intenzioni della stessa rivelazione cui affermano di credere, non elaborandone i principi alla luce dei cambiamenti.
3- Il Corano, la Sunna e i precetti dei giuristi (fiqh)
Come suggerisce anche il fatto che lo stesso Corano è composto in sostanza da due gruppi di versetti – quelli medinesi e quelli meccani – diversissimi tra loro per forma e contenuto, poiché riferiti a periodi storico-politici diversi, l’elaborazione della Shari’a ha preso forma in stretta relazione con la realtà dell’Islam nel corso della sua evoluzione, a partire da circa 300 anni dopo la morte del Profeta; è stato (e dovrebbe tuttora essere) il frutto di un perpetuo processo negoziale scaturito dal continuo cambiamento delle circostanze storiche e politiche.
Le fonti primarie della Shari’a, con cui si confrontano i fuqawa appartenenti alle diverse scuole giuridiche – nel mondo sunnita quelle hanafita, shafeita, malikita e hanbalita, che specie nel diritto di famiglia possono divergere molto tra loro – sono il Corano e la Sunna (l’insieme degli atti e dei detti del Profeta Maometto, classificati nel corso dei secoli in alcune celebri raccolte). I fuqawa analizzano queste fonti e le interpretano alla luce della cultura locale, servendosi anche di altri strumenti a loro disposizione: il qiyas (ragionamento analogico, basato sulla esistenza di un precedente giuridico) e l‘ijma, cioè il “consenso dei dotti religiosi”, supportati in via accessoria da altri criteri come l’equità (istihsan), l’interesse collettivo (maslaha), la consuetudine e i costumi locali (Urf) e la presunzione di continuità (Istihsab) rispetto al percorso di una delle scuole giuridiche. L’utilizzo di questi strumenti dà luogo all’esercizio dell’interpretazione (ijtihad) della Shari’a. In questo modo, i giuristi producono il Fiqh, la giurisprudenza islamica, analogamente a quanto i rabbini fanno con la Halakha (reso di solito con “legge ebraica”), traducendola in singole leggi o disposizioni.
Il Fiqh regola la dimensione del culto e dei rituali religiosi (ibadat), quella delle credenze generali (Itiqadat), degli affari sociali come i contratti e le transazioni (mu’amalat), della condotta personale (adab) e quella delle punizioni (uqubat). Nel Corano, solo 80 versetti sui 6236 totali riguardano specifiche ingiunzioni legali. Shari’a e Fiqh interagiscono, e designano concetti diversi: la prima è immutabile, perché attiene ad un indirizzo generale di matrice divina; l’essenza della seconda sta invece nella sua discutibilità, poiché implica l’elaborazione umana. Ed è la seconda a poter essere tradotta con “(elaborazione della) legge islamica”, non la prima.
Chi si oppone, da una prospettiva islamica, alla applicazione delle pene corporali decisa dai giuristi in determinati paesi, lo fa nel nome della distinzione tra questi due concetti: non farlo significherebbe equiparare Shari’a (divina, infallibile, generale) e Fiqh (umana, fallibile, specifica). Ciò è ancor più vero se si pensa che nell’Islam non esiste una gerarchia ecclesiastica come nel Cristianesimo, così come non esiste la nozione di infallibilità papale (dei giuristi, nel caso islamico), non essendoci una figura speculare al Papa.

4- Punizioni corporali e omosessualità
Le femministe musulmane, ad esempio, fanno riferimento al Fiqh e ai “principi della Sharia” per opporsi a questa o quella legge, discutendone i fondamenti. I riformisti islamici contemporanei, che sostengono gli sforzi interpretativi volti a modernizzare le leggi islamiche, depurandole da quelle anacronistiche, partono anch’essi proprio dal Corano per dare forza alle loro affermazioni. Esse partono anzitutto dall’idea della Shari’a come un “consiglio”, un “indirizzo”, più che un obbligo religioso. Questo sostiene il versetto 256 della Sura 2 (“non c’è obbligo nella religione”), il versetto 123 della Sura 20 (“Chiunque segua la mia guida non sarà smarrito, e chiunque gli volti le spalle avrà una vita piena di difficoltà”), il versetto 29 della Sura 18 (“La verità è giunta da te, oh Signore: permetti a coloro che la desiderano di crederci e a coloro che la rigettano di non crederci”), o il versetto 31 della Sura 13 (“Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola persona / avrebbe guidato ogni persona”).
Nel merito delle punizioni corporali, come quelle annunciate in Brunei o quelle vigenti in Arabia Saudita, va detto che anche da una prospettiva giuridica islamica le cose sono più complesse. Prendiamo il caso della punizione per l’adulterio: è vero che nel Corano, al versetto 2 della Sura 24, si parla di “80 frustate” (non di lapidazione, che era invece una pratica già in voga prima dell’avvento dell’Islam, disposta ad esempio dalla stessa Halakha) ma ciò che raramente viene spiegato è il procedimento col quale queste pene potevano (e potrebbero, in una prospettiva “islamicamente” corretta) essere rese esecutive, il ché scava un abisso tra dimensione teorica (le pene come deterrente) e pratica (le pene come effettiva misura applicata).
Se ci si ferma appunto al Corano, cioè alla principale fonte della Shari’a, si nota che nel versetto 15 della Sura 4, si esplicitano le condizioni per poter comminare una sanzione per adulterio, e cioè la presenza di quattro testimoni indipendenti, che “siano testimoni con i loro occhi” della consumazione di un rapporto: una eventualità piuttosto rara, se non impossibile. Nei versetti 4, 5, 6, 7, 8 della Sura delle donne, poi, si mette in guardia dal reato di falsa testimonianza, il quale porterebbe lo stesso falso testimone alla condanna ad 80 frustate e alla privazione ab aeterno della possibilità di testimoniare in futuro. Una sorta di marchio di infamia.
Lo stesso meccanismo vale poi per i rapporti omosessuali, oggetto della notizia citata in testa all’articolo. I Paesi che eseguono sentenze non rispettando questi criteri non applicano in alcun modo “la Shari’a” ma sono fautori di un loro approccio specifico (oppure recuperano leggi dei tempi coloniali), al quale per ragioni reputazionali conferiscono una esteriorità islamica. Non si spiegherebbe, d’altronde, come mai il Califfo ottomano Abdulmecid I, nel 1858, depenalizzò l’omosessualità, rifacendosi proprio ad un hadith (un “detto”, contenuto nella Sunna) del Profeta, che durante il suo “governo” sulla Umma proibì la violenza e raccomandò “gentilezza” nei confronti dei mukhannatan, degli “effeminati”, di fronte ai quali le donne potevano non indossare il velo.
I giuristi musulmani dei giorni nostri – che si rifanno tutti, ovviamente, ai principi della Shari’a – rispetto all’omosessualità hanno approcci eterogenei. Insistono però su un punto comune a tutti i monoteismi: l’omosessualità (intesa come attrazione verso persone dello stesso sesso) come una condizione semi patologica (stimolata dal “demonio”), non punibile in sé stessa, per la quale si raccomanda la castità, l’astensione dal consumare effettivamente dei rapporti sessuali illeciti pur in presenza di un desiderio (da reprimere).
Non è forse un caso che, a differenza di quanto fatto da diversi quotidiani italiani, nel dare la notizia sulle punizioni nei confronti degli omosessuali in Brunei, i giornali stranieri non abbiano mai sentito il bisogno di menzionare la parola “Shari’a” nel titolo, limitandosi a parlare di “introduzione di pene corporali e della pena di morte”. Che poi è esattamente ciò di cui si dovrebbe parlare.