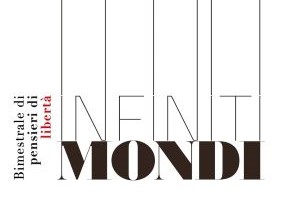Il brano seguente rappresenta, crediamo, l’ultima partecipazione pubblica del grande critico Arcangelo Izzo, intervenuto in veste di “esegeta” alla mostra dello scultore Ciro Maddaluno, tenutasi alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto nella primavera del 2008.
Oggi non sono certo che tutte le parole ivi riportate corrispondano fedelmente a quelle pronunziate allora dall’acuto Arcangelo. Ma non v’è modo, ormai, di sapere se e quanto vi aderiscano. So solo che quanto traduco qui, rappresenta l’emozione ch’egli suscitò a chi, in quel momento, viveva le tensioni di questa koinè dell’arte e la consapevolezza del tramonto di una stagione magica che aveva visto Napoli tra i luoghi protagonisti del dopoguerra.
Emerge nella narrazione, a momenti lucida e per lunghi tratti visionaria, raccolta con mezzi di fortuna costituiti da un minuscolo notes e una matita spuntata, la caparbia volontà del vecchio di riannodare i fili di un mondo ormai evanescente, che assume i tratti enigmatici del simbolo dietro gli occhi appannati che guardano già oltre.
Questo commovente discorso, adeguato alla necessità di quella circostanziale presentazione, in cui alla severa analisi che lo aveva storicamente contraddistinto Izzo sostituiva una sorta di annuncio di un paradiso cui anelare, una Biennale mitologica, sorta Walhalla degli artisti, ci sembrò, essendo ormai prossimi alla chiusura del testo, la giusta pagina per chiosare questa raccolta di testimonianze. Il discorso di presentazione ci parve cioè riassumere le tante voci di una città ormai orfana degli spazi storici dell’arte: quello di Amelio prematuramente scomparso; quello di un Morra ormai ritirato; quelli mediatici di Castellano, pure scomparso. Significando bene la fisionomia di un tramonto del “contemporaneo”, che a Napoli aveva beneficiato di una grande rilevanza internazionale ma s’avviava ad eternarsi nelle tracce di ciò che era stato, permanendo nel presente come i calchi di Pompei, che paiono vivi e ci trasmettono l’istantanea di qualcosa che non è più.
Pensiero Archeologico e mitologia della Biennale: appunti spersi da una presentazione di Arcangelo Izzo.
« Il pensiero estetico napoletano, pensiero congenitamente diffuso, esprime amore per l’arte piuttosto che per gli artisti. Una categoria estranea alle suggestioni delle personalità e del mercato ed estranea alle cose perfettamente inutili che toccano solo i margini della vera essenza del pensiero creativo.
La logica estetica napoletana è una solida struttura che resiste alla storia con grande saldezza di pensiero e di azione.
È spirito che sovente si manifesta come ricerca dell’incontro, del bacio d’amicizia, che non tradisce. L’impegno dell’uomo che nell’estetica, sia essa intenzionalmente artistica o meno, cerca di affermare ciò che latente diventa esistente.
Un modo che si esplica in quel “Quod latet patet”, un principio che accompagna questo pensiero estetico sin dalle origini… “solo ciò che si nasconde s’avvera”.
Principio che ridefinisce l’arte, o semplicemente, il fare creativo, non più secondo consueti accenti e accenni, ma verso la sua parte più consistente, verso ciò che continuamente affiora e prende consistenza come forma d’amore. Un carattere che esprime autentica e profonda sensualità.
Un canto, quello di una folla presente e passata, di trapassati, che continuano l’esistenza affacciandosi dalle antiche mura della città.
Per questo la profonda importanza e l’inalterato interesse per l’archeologia; per l’archeologo che accompagna mostrando allo straniero la vita, antica e presente, che è metafora del dischiudere l’uscio della propria casa – e quella dei propri avi – all’ospite.
Gli avi, che non sono esseri distanti, “altro” dal presente, sono solo esistenze sospese; quelle esistenze chiamate agli dei perché troppo amate; ironicamente disgiunte dalla cronaca per consegnarsi all’eternità. Lo sguardo arguto e distaccato di Menandro.
Ma non è uno spirito noir quello del pensiero estetico napoletano, è piuttosto esaltazione della vita passando per la materia, oltre la caducità della materia stessa; in base a un principio di latitanza e di latenza. Un tutto che si fa icona e vive in un Iperuranio che nel nostro tempo assume il nome di “Biennale”.
Pensiero che si fa grido di pericolo…ma non solo per l’invasione del rifiuto; esso è – molto di più – grido per la dispersività epocale verso l’immateriale.
Così l’astuzia dell’archeologo che riconduce il passato, la memoria, al presente e al peso della materia, cristallizzata. Materia che è rigonfiamento, nel flusso della storia, liberata – a dispetto dell’approccio ingenuo – dalle ragioni della cronaca.
Questo è il legame tra il Luogo e Kiefer che contorce il piombo e il ferro come una magia da rabdomante che cerca l’acqua per irrorare i campi aridi; e quello di Beuys, il grande tedesco, che espone pietre laviche, non adulterate da nessun agente, quale rappresentazione della materia viva, come le croste delle ferite; della riflessione estetica, Bonito Oliva, ovvero, il testimone che gioca a rintracciare l’archeologia attraverso la cornice della Biennale.
L’ esteta si fa archeologo e, perdendo il filo della cronaca, diventa egli stesso icona salvandosi dal flusso del tempo, eternamente giovane, attraverso il nutrimento dell’anima.
L’archeologo ci mostra cose sempre vive che non possono essere oscurate.
Il pensiero estetico napoletano, che è lo stesso se dicessimo il “pensiero dell’archeologo”, è interruzione fortuita, sguardo estraniato sul flusso della storia, e serve a dare la dimensione delle ansie e delle attese sociali. Dei torti… e delle ragioni… di una comunità che è, in sé, una categoria del pensiero. Per meglio comprendersi… che è come dire: per meglio comprendere l’ “arte”, altra categoria del pensiero passata dal transiente all’immanente; dal flusso della storia all’essere in sé dell’archeologia.
È un spirito che circoscrive e totalizza, come Kiefer, già architetto che trascende l’architettura attraverso forme ibridate.
È l’espressione estetica che guardata si affaccia dentro il mondo e lo assume (non è, viceversa, il mondo che la assume).
Essa viene a sollecitare il sorriso, a suggerire il diritto al sorriso e il dovere della felicità. Espressione che viene letta, a tratti, folle e al limite del fanatismo; ma che riconduce a Schopenhauer, che ci suggerisce come il pazzo, il fanatico, sia il solo che riesca a parlare della felicità come una cosa grandemente assoluta e sublime.
Il pensiero estetico napoletano si colloca nell’evo del post umano, dell’immateriale, come opera degna di fronteggiare i secoli e vivere la modernità senza inganni e senza falsità.
Gli artisti sublimano l’esistenza mutuando i simboli e gli archetipi lasciati in eredità dai propri avi, consacrando –al medesimo tempo- una memoria che dona vita imperitura.
Questa è l’arte; tragedia dell’esistenza risolta con la leggerezza del sorriso.
Questo, evidentemente, il pensiero che animò l’ avanguardia degli anni ’60, la cifra leggera e soave, da adottare come propria, nel dialogo col mondo.
Dove si trova allora questa categoria del pensiero estetico? Dove si colloca? Nel “paradiso della Biennale”. Sia essa considerata come una riserva dell’intelletto dove trarre ristoro; un lenitivo trascendentale dell’anima …come il saluto dell’angelo, del poeta Rilke, in un pomeriggio incendiato che declina a sera.
Sia questa riflessione sul contributo dello spirito napoletano, portato a diventare mito, illustre, che glielo riconoscano o no; un tributo a una comunità che, unica, è in grado di diffondere e preservare la parola dell’arte…la qualità, unica, di chi trova una via altra alla grande bugia della critica, fuoco fatuo nel cimitero della virtualità ».
di Gennaro Avano