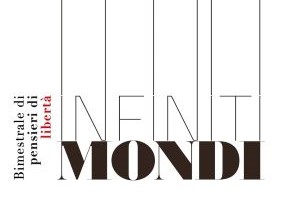di Achille Flora
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha sollevato le proteste delle Regioni meridionali, limitate all’ammontare dei finanziamenti, basate sull’entità della popolazione meridionale pari al 34% di quella italiana, senza considerare gli altri parametri che determinano per il Mezzogiorno una quota del 70% dei Fondi strutturali. Una protesta tardiva, considerando che tale percentuale era già inserita nel Piano Sud 2030, elaborato dal Ministro Provenzano. Una percentuale che, per essere riconosciuta, ha richiesto l’impegno e una presa di posizione netta da parte del Ministro Provenzano, poiché quella antecedente era ferma intorno al 20%.
Quello che più colpisce di questa mobilitazione è l’esclusiva attenzione alla mole di denaro che potenzialmente dovrebbe arrivare nel Mezzogiorno, alimentando uno scontro frontale tra Nord e Sud. L’idea di base, di origine Svimez, condivisibile, è che per far riparte lo sviluppo italiano, superando le disuguaglianze territoriali, sia necessario non limitarsi a far partire il motore del Centro-Nord, ma attivare anche quello meridionale, per le ricadute che questo avrebbe anche sull’economia nazionale. Solo che le Regioni intravedono il carburante di questo motore solo nei mezzi finanziari, trascurando lo stesso impianto del PNRR che prevede strette connessioni tra investimenti e condizionalità, date dall’attuazione di riforme strutturali. In primis la Riforma delle Pubblica Amministrazione e la sua evoluzione digitale, per superare lentezze e ossessione burocratica ai regolamenti, senza alcuna attenzione ai risultati.
Il “motore dello sviluppo” è un sistema complesso, la cui alimentazione non avviene solo rifornendolo di risorse finanziarie, ma è sensibile ai ruoli amministrativi, al funzionamento del sistema giudiziario, così come alla presenza di diseguaglianze territoriali, di genere o di appartenenza. Quello che si sottovaluta è il ruolo delle istituzioni, la loro efficienza ed efficacia che ne condizionano i risultati, dimenticando i fallimenti nelle politiche di coesione, sia nel promuovere sviluppo, sia nelle difficoltà nel progettare e spendere le risorse assegnate.
Del resto l’impianto del PNRR non prevede di fornire direttamente risorse finanziarie alle Regioni. Il suo modello operativo è, sostanzialmente, del tipo “top-down”, anche se le modalità della sua gestione non sono ancora chiaramente definite. Il Piano, stabiliti gli obiettivi di sviluppo (le Sfide), si articola in Missioni che rendono concrete le sfide, in aree d’intervento suddivise in clusters, dove raggruppare singoli progetti. Le Regioni potrebbero avanzare progetti capaci di connettere i piani nazionali con le realtà locali dimostrando, come prevedono i regolamenti europei, che tali progetti consentono di potenziare il risultato dello sviluppo territoriale.
Non si dovrebbero ripetere gli errori verificatisi con altri Piani Nazionali. Penso al Piano della Portualità e della Logistica, dove il potenziamento dei Porti è avvenuto senza che le Regioni intervenissero per migliorare e potenziare i collegamenti infrastrutturali tra i porti e i raggruppamenti d’imprese, oramai lontani dalle aree portuali. Si veda il caso della Campania, con il ritardo con cui si sono realizzati i collegamenti ferroviari tra porti e interporti. Così come langue il dibattito sul piano strategico meridionale, dopo il tramonto dell’opzione di attrezzare i porti per farne degli Hub nell’ambito delle nuove vie della seta, oramai assegnata ai porti settentrionali (vedi Trieste) per le carenze di collegamenti infrastrutturali.
C’è un altro problema inerente all’approccio seguito dal PNRR ed è quello di eludere il tema della partecipazione.
Gli interventi cadranno sui territori senza che la popolazione locale ne sia partecipe e cosciente. Una mancanza grave, particolarmente nel campo della tutela e rigenerazione ambientale, poiché non è possibile una svolta su questi temi senza la partecipazione e la ricostruzione di un rapporto virtuoso tra popolazione e territorio.
Il problema è chi organizza questa partecipazione. È sufficiente affidarsi a gruppi autodefinitisi come “società civile”? In realtà, tali raggruppamenti, privi di una base territoriale, hanno un carattere prettamente politico e si basano su componenti elitarie (professionisti, accademici, politici) per elaborare programmi d’intervento, come fossero un partito. Rappresentano un “civismo politico”. Altra cosa dal senso civico che promuove solidarietà. de Tocqueville, cui si è ispirata la scuola civica americana, nel suo viaggio in America, non fu colpito dalle èlite, che ancora non si erano formate, ma dal fatto che, pur in “eguaglianza delle condizioni” operatori economici e popolazione, di fronte ad un problema, si organizzassero per risolverlo. Era una partecipazione attiva, era civismo sociale, non politico.
Chi può oggi essere presente e attivo nei quartieri e nelle periferie più povere per dare ascolto alla popolazione e risposte ai problemi? Chi può costruire la partecipazione?
I partiti, frammentati in gruppi di potere e comitati elettorali, sembrano lontani da queste tematiche, mentre i gruppi della società civile, pongono il problema attraverso enunciazioni di principio. C’è bisogno, invece, di ascolto della popolazione emarginata, di dar voce agli invisibili, di organizzare forme sindacali di tutela delle nuove tipologie di precariato partorite dal post-fordismo. C’è bisogno di costruire coesione e non solo di enunciarla teoricamente.
Achille Flora