Trovo affascinante e notevole la novella di Daniele Maria Pegorari, L’urlo della farfalla, pubblicata su «la Gazzetta del Mezzogiorno» il 31 marzo 2020 e poi anche sulla versione online del quotidiano, il 10 aprile. Pegorari è professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Bari, autore di parecchi volumi e saggi che mi coinvolgono e mi piacciono per la grande chiarezza unita al rigore. Questo è il suo primo scritto creativo. Sorpreso per la novità di questo suo, spero non unico, esperimento di scrittura narrativa, ho interrogato lo studioso che mi ha risposto così:
«Sentivo il bisogno di esprimere in una forma eccezionale una condizione eccezionale. Mi è parso che fare critica in questo specifico momento storico non potesse significare scrivere il trecentesimo saggio di italianistica. Viene il momento in cui la conoscenza scientifica deve applicarsi a una presa diretta sulla realtà».
Trovo interessanti nel testo, come lettore, squarci da the day after o inquadrabili piuttosto in una letteratura fantascientifica e distopica; una situazione da ‘dopo virus’ eppure tremendamente realistica e attuale. Una novella, questa, che comunica un punto di vista molto scettico sulle possibilità di cambiamento di una società «inquinata alle radici» – come direbbe lo Svevo di “La coscienza di Zeno” – per cui la retorica del ‘tutto come prima’ o ‘niente come prima’ si equivalgono, gattopardescamente. Lo leggo nell’impossibilità del volo della farfalla, come nella sua orribile metamorfosi e scomparsa alla fine della novella:
ad un tratto, i colori delle sue ali impallidirono, si confusero come pastelli maldestramente adacquati e divennero un’indistinta pozzanghera secca; le membrane apparvero dapprima gigantesche, poi rapidamente rattrappite e aggrinzite, fino a spezzarsi;
È anche l’allegoria della fine di un sistema globale che si è allontanato predatoriamente e proditoriamente del tutto, senza correttivi, dall’equilibrio naturale. Mi sembra un tocco un po’ fortiniano, ma rovesciato rispetto all’ottimismo profetico della celebre poesia “La gronda” tratta dalla raccolta “Una volta per sempre” (1963), in cui il breve posarsi di una rondine su una gronda, troppe volte riparata, di una casa fatiscente e il suo volo segnano «irreparabilmente» il crollo della vecchia società capitalista e l’avvento di un mondo del tutto nuovo, abitato da «generazioni di giovani che saranno più felici di noi e non avranno nemmeno bisogno di sapere da quale mondo atroce noi eravamo circondati» (Fortini). Sono versi, quelli di Fortini, che recito quasi ogni giorno, come un mantra, circondato, ahimè, come tutti, dal marciume contro cui le piccole, frequenti riparazioni della casa comune e la gioiosa inconsapevolezza del Paese di Bengodi valgono poco o nulla:
Penso con qualche gioia
che un giorno, e non importa
se non ci sarò io, basterà che una rondine
si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti
irreparabilmente, quella volando via.
Due voci eretiche e di sinistra, quelle di Fortini e di Pegorari, ma in questa scrittura extra-vagante dell’italianista barese si coglie tutto il pessimismo di un nuovo secolo, causato dall’assenza di un orizzonte politico e morale all’altezza della ricostruzione che sarà necessaria. Negli anni ’60 di Fortini c’era ancora spazio per l’utopia e per il volo di una rondine. Il finale sospeso, eppure allusivamente pessimistico, di Pegorari è indice di un salto antropologico, di una collettiva caduta nel vuoto.
Carlangelo Mauro
Daniele Maria Pegorari (Bari, 1970) è professore di Letteratura italiana contemporanea, Sociologia della letteratura e Letteratura italiana nell’Università degli studi “Aldo Moro” e condirettore di «incroci», semestrale giunto alla XXI annata. Ha pubblicato numerosi libri, fra cui tre su Mario Luzi (1994, 2002 e 2006), il Vocabolario dantesco della lirica italiana del Novecento (2000), Critico e testimone. Storia militante della poesia italiana 1948-2008 (2009), Les barisiens. Letteratura di una capitale di periferia 1850-2010 (2010), Il codice Dante. Cruces della ‘Commedia’ e intertestualità novecentesche (2012), Umberto Eco e l’onesta finzione. Il romanzo come critica della post-realtà (2016), Scritture precarie. Editoria e lavoro nella grande crisi 2003-2017 (2018), Letteratura liquida. Sei lezioni sulla crisi della modernità (2018) e Amleto o lo specchio oscuro della modernità. Tre secoli di riscritture italiane 1705-2019 (2019). È stato curatore scientifico dal 2012 al 2015 degli “incroci po/meridiani”, nel 2013 delle giornate universitarie per il bicentenario della Bari murattiana, nel 2015 delle celebrazioni cittadine per il 750° anniversario della nascita di Dante, nel 2016 del festival “Le notti dei poeti” e nel 2017 della mostra “Scatti di poesia”.
https://incrocionline.wordpress.com/
L’URLO DELLA FARFALLA
un racconto di Daniele Maria Pegorari
I temuti incendi non si erano verificati, per buona sorte. La pioggia delle ultime settimane aveva raffreddato gli impianti che, privi di governo, si andavano pericolosamente surriscaldando.
Scostò la tenda da cui per tutto quel tempo aveva cercato i segni della fine, qualcosa che somigliasse a un arcobaleno; non si aspettava certo di vederlo di sette colori, si sarebbe accontentato di molto meno, anche solo di una fiumana aerea di grigi. Aveva imparato ad amare il grigio, nelle sue mille gradazioni, nelle sue segrete parentele con tutti i colori. Da quando il cielo aveva smesso di essere azzurro, da quando le aiuole si erano coperte di piume, da quando il ricordo di tanti volti si era sbiadito come il riflesso di un bicchiere, non conosceva che il grigio, e si era impegnato, giorno dopo giorno, a riconoscervi le memorie di celeste e di verde, di porpora e di arancio. “Non esiste un solo grigio”, si ripeteva con scrupolo metodico ogni mattina, quasi una ginnastica della mente e degli occhi, e si ricordava di una poesia studiata all’università, che aveva su di lui l’effetto di un accordo stonato, di un gessetto sulla lavagna, di un’unghiata sui vetri: Già goccia la grigia rosa il suo fuoco, il fuoco rapito fumido di pioggia. Due versi che gli vibravano sotto la pelle come una febbre: una febbre grigia, appunto, ma memore di una vita trascorsa o ancora in attesa di sbocciare, sotto qualche roveto non più ardente.
Da qualche giorno non si udivano né elicotteri sul carcere, né altoparlanti minacciosi, né notiziari a reti unificate. Nessuno più sventolava, di notte, le torce elettriche dagli oscurati balconi, nessuno – o almeno così dicevano – veniva più localizzato e spiato da droni e microchip tatuati sotto pelle, nessuno più indossava caschi protettivi, poiché, diceva la vicina di casa, non piovevano più le squame del cielo. Molti le chiamavano così, in mancanza di una sicura denominazione scientifica, “le squame del cielo”, ma c’era chi s’arrabbiava, perché il cielo non ha squame, si sa, non è mica un pesce. E se il cielo non è un pesce, non possono cadere squame.
Per la verità neanche quel giorno, dietro i vetri incrostati, era apparso nel cielo alcun segno confortante, ma dal quartiere proveniva un chiacchiericcio dapprima sommesso, poi sempre più distinto che sembrava chiamarlo come l’eco di una voce fraterna. Più ancora poté la stanchezza per la troppo lunga reclusione, che spinse Martino a scendere le quattro rampe di scale e a ritrovarsi in strada. Se poteva dirsi ancora una strada, quella, o non piuttosto una distesa di batuffoli bianco-grigiastri che non lasciavano intravedere nulla dell’asfalto e rendevano ogni passo dapprima curiosamente morbido e divertente, poi sempre più faticoso. Martino sollevava a stento i piedi e li riaffondava in quell’incredibile distesa di polline trasportato in città da un insopportabile vento che era durato, quanto? settimane, mesi? In quei mesi il tempo non si era arrestato, aveva solo cambiato andatura, aveva deciso di liberarsi dalla proterva scansione di orologi e calendari, e andava per conto suo, annottando quando Martino avrebbe voluto parlare con qualcuno, albeggiando quando aveva sonno, nevicando d’estate o spingendo al di là delle cimase, avvolte dalle ombre del tedio invernale, una feroce spera solare: allora, dalla sua speciale tavolozza di grigia poesia, gli sovveniva il verso di un altro secolo – Già di cerulea gioia rinnovasi ogni pensiero – e ne sorrideva, pensando a quanto leziosa sapeva ancora essere la sua memoria di carta, pur in una condizione come quella.
E ora giungeva questa immane primavera che col suo polline si era presa tutto lo spazio della città, sterilmente posandosi su strade e marciapiedi che non avrebbero potuto fecondarsene e strozzando il respiro e cuocendo gli occhi e le mani che, dapprima timidamente, poi sempre più febbrilmente aprivano i portoni dei palazzi e sollevavano le saracinesche dei negozi e dei bar, arrugginite e rumorose. Un rumore assordante, epico, rintronava nelle orecchie di Martino, mentre i suoi passi affondavano pesantemente in quei gomitoli, da cui talvolta spuntavano guanti di lattice rivoltati, mascherine sformate e fogli di giornale: relitti di un’umanità che aveva conosciuto prima l’informazione della paura, poi la paura dell’informazione, disperdendone infine gli scarti sotto gli schiaffi di quel lento libeccio.
Martino registrava con cura la vita che riprendeva la sua gara col nulla: la città degli affari e dei malaffari rispondeva con prontezza alla propria legge cibernetica. Tutto rientrava nelle forme antiche, quelle rivestite prima che il morbo cominciasse. Martino proseguì la sua insulsa e ammutolita peregrinazione, interrogando i passanti con lo sguardo, chiedendo se davvero pensassero che di questo si era trattato, di un morbo cominciato, o non piuttosto, di un mondo finito.
E la risposta che trovava era appunto quella: occorreva far tornare in forma il mondo, ri-formarlo, ripristinarne la scenografia come se nulla fosse accaduto. Tutto come prima di quel giorno in cui il mondo aveva dichiarato guerra al morbo e aveva vinto. L’orrore dei giorni, delle settimane, dei mesi trascorsi nell’isolamento e nell’oscurità si trasformava in una gigantesca indulgenza verso il passato, a cui ognuno ora si aggrappava come fosse la sola possibilità di sopravvivenza.
Tutto come prima ripetevano i politici molto onorevoli, tutto come prima assicuravano i leader delle parti sociali – che scialba espressione –, tutto come prima garantivano, pur senza mai aprire bocca, gli immortali capicosca. E tutto come prima diceva singhiozzando anche la vicina di casa, perché questo sa implorare un’umanità disperata a cui nessuno ha insegnato a pensare che tutto potrebbe essere diverso, dopo. È la storia terribile di ogni guerra che, da un lato, lascia sul terreno decine di migliaia di morti, sciacallaggi e coprifuochi e, dall’altro, costruisce altari per i suoi miti necessari, i martiri, i santi miracolosi, gli eroi che poi dovrà onorare al momento del ritorno alla normalità, quando si celebreranno le giornate nazionali o mondiali del “Mai più”. Martino guardava attonito questa città che si ridestava uguale a quella di un tempo, ma più vecchia, come segnata da rughe e muffe secolari, e si chiedeva se dovesse temere di più il ritorno del morbo o il ritorno a quel tempo precedente, in cui il nemico pestilenziale era covato nelle viscere del mondo e si vendicava della sua stoltezza.
Nonostante l’orma del dio vendicatore si nascondesse con arguzia nel suo stesso nome, Martino non avrebbe voluto saperne né di vendette né di guerre; piuttosto si ostinava a curare con meticolosa applicazione le piante del suo terrazzo – un limone, qualche succulenta, numerosi vasi di glicine, un bonsai – nella convinzione che da quell’arte si potesse apprendere il segreto della morte per la vita, della fine per il principio, dell’agonia per la vittoria. Lo fece anche quel giorno in cui il mondo aveva deciso di ri-formarsi: tornato a casa, passò dalla sua biblioteca e uscì sul terrazzo, ricominciando con pazienza a pulire i rami spinosi del limone dalla bava grigio-lattea della cocciniglia.
Quand’ecco l’inaspettato miracolo: un’enorme farfalla si posò sulle foglie all’altezza degli occhi di Martino. Fu un interminabile istante in cui le centinaia di minuscole lenti del lepidottero scavarono nella profondità dello sguardo di lui e sembrarono implorare pietà, urlando una disperazione che giungeva dall’abisso di un sogno lontano e perduto. Poi, ad un tratto, i colori delle sue ali impallidirono, si confusero come pastelli maldestramente adacquati e divennero un’indistinta pozzanghera secca; le membrane apparvero dapprima gigantesche, poi rapidamente rattrappite e aggrinzite, fino a spezzarsi, sfarinarsi desolatamente ai piedi del vaso.
Fu allora che Martino rientrò in biblioteca e accese un fiammifero.
Bari, 25-30 marzo 2020
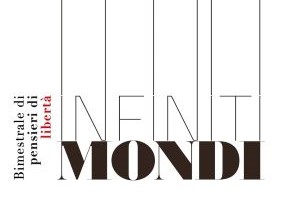


GRAZIE per aver ricordato Fortini ( domani cercherò sue poesie) e grazie a “L’urlo della farfalla” che ci spinge a pensare di più. Si, domani però.
Bellissimo racconto!