Come molte e molti, faccio ordine nel passato per prepararmi al futuro. Anche tra i file. E così è saltato fuori questo piccolo testo, scritto una quindicina di anni fa, in occasione dell’uscita dell’edizione rivista (la prima era del 1996) de Il pensiero Meridiano di Franco Cassano. Mi sembra che queste righe oggi mostrino un senso ancora più pieno.

È un libro nel quale, incrociando sociologia, poesia e politica, propone una riformulazione dell’immagine che il Sud ha di sé e il conseguente ripristino della sua dignità di soggetto di pensiero, in grado, pertanto, di elaborare e proporre modelli altri dello stare al mondo.
Le linee attraverso le quali Cassano conduce la sua riflessione appaiono “secondarie” rispetto al rigore teorico delle strutturazioni della moderna tradizione di pensiero forte che, pur avendone ormai perso il controllo, ancora domina l’organizzazione mondiale così come oggi la conosciamo.
Ma una via secondaria è tale solo in relazione alla categoria di tempo: non lo è stata ieri, potrebbe non esserlo più domani. E lungo le vie secondarie, dove il rumore del traffico si attenua, si possono ascoltare suoni nuovi o dimenticati, scoprire o rivalutare modalità di cammino diverse, prestare attenzione agli scarti, alle dissonanze, a ritmi segreti.
Cassano incentra il suo ragionare sul luogo fisico del Mediterraneo storicamente determinato, ma anche che vi ricorra come metafora eccellente d’irriducibilità delle differenze.
Alla identificazione del progresso con l’accelerazione, oppone un provocatorio Elogio della lentezza, un procedimento per maturare una concezione ecologica di sviluppo, in grado di preservare la memoria e con essa forme di esperienza preziose che, per esistere, hanno bisogno di un tempo dal respiro lungo. La tirannia dei consumi ha corroso alle radici il concetto stesso di durata, causando la contrazione del Tempo in un’unica dimensione, quella del presente. Il futuro non orienta più l’azione umana. Le conseguenze sono allarmanti, ma ancora pochi quelli che si lasciano allarmare. Il problema è immaginare un’alternativa al “misero monoteismo del progresso («non avrai altro sviluppo all’infuori di me»)” e al ritmo ossessivo dell’accumulazione che lascia indietro chi non ce la fa.
Nella costruzione di un nuovo senso, la rivalutazione del concetto di Misura, che porta con sé quello del peccato di hybris, diviene l’orizzonte di un’ecologia culturale nel quale il senso del limite sia forma di convivenza, di sviluppo sostenibile, di radicale opposizione alle spietate disuguaglianze.
Questo concetto di misura sembra appartenere naturalmente al Mediterraneo che fissa le distanze solo tra terra e terra, in opposizione alla dismisura dell’oceano. La sua peculiare intimità alla terra ne fa luogo di contraddizioni. È un mare abitato e solcato, è interno ed esterno, è navigabile dal piccolo cabotaggio, ma è squassato da improvvise, violente burrasche che evocano il furioso dispetto di divinità permalose. La terra, quasi sempre a vista, non è più rassicurante di un previsto vento costante che spira sull’oceano.
Nell’immaginario letterario, il Mediterraneo è sempre percorribile nei due sensi della partenza e del ritorno. Da Ulisse in avanti, è un mito reversibile perché contiene in sé l’insopprimibile slancio ad andare e la nostalgica tendenza a tornare. Il Mediterraneo costringe ad ammettere la scissione ospitata in ciascuno di noi, tra il fissare la prora su una rotta come atto di libertà individuale e custodire le relazioni e gli affetti in un luogo socialmente condiviso. I popoli mediterranei sono esposti costantemente all’irraggiamento di queste contraddizioni e fanno esperienza diretta del limite che mare e terra si danno reciprocamente.
Del resto, una delle più arcaiche testimonianze di questa locale attenzione al limite la si può rintracciare, nella formulazione biblica della legge del taglione che impone una misura, istituendo un limite alla punizione, una corrispondenza fissa, oggettiva e non soggettiva, tra l’offesa e la punizione.
Chi abbia esperienza di navigazione a vela avvertirà, forse, una certa confidenza con questi temi. Potrà cogliere, forse, prima ancora che con la testa, la brezza fresca del pensiero sulla pelle.
Navigare a vela è, innanzitutto, conoscenza e prudenza, è negoziazione, è una forma di cooperazione tra un Golia e un Gigante, è perseguimento costante e inevitabile di equilibrio. Tutte modalità consonanti con il sentimento di misura.
Navigare, da sempre, significa conoscere e capire la cultura del mare, non farvi un semplice giro turistico, cioè, ma apprendere in profondità la sua grammatica e imparare a usarla.
Tuttavia, il progresso tecnologico, la disponibilità di propulsori, materiali e strumentazioni sofisticatissimi e l’accelerazione delle procedure resa possibile dal loro impiego, ha deteriorato esperienze, competenze, saperi antichi, travolti e superati dall’assistenza alla navigazione satellitare e digitalizzata.
La vela, in questo senso, si pone come un fattore di resistenza (parziale) all’omologazione e alla perdita di memoria. E, perché no, anche alla perdita di capacità di previsione. Chi naviga a vela conserva il tempo per guardare il cielo e fiutare l’aria.
Prima di essere per noi, il mare è per sé, è un universo pullulante di altre forme di vita e regolato da altre leggi.
La navigazione a vela implica un approccio rispettoso con questo universo, procede non con lo slancio rettilineo del conquistatore, tipicamente terrestre, ma bordeggiando, accostando, risalendo il vento o raccogliendolo nelle vele lascate. È laboriosa bellezza del mediato contro la facilità dell’immediato, è il piacere (ma anche la paura, la sofferenza a volte, o la noia) protratto, consumato lentamente. È sapienza misurata in centimetri di scotta da cazzare o mollare. È una forma di meditazione corporea, un’attenzione alla relazione fisica tra gli elementi e noi stessi e alle reciproche influenze.
È un pensiero di vento e d’acqua che può dispiegarsi solo in un tempo diversamente veloce.
Navigando a vela, anche nelle acque interne di una città parossistica come Napoli, si scopre il silenzio abitato della distanza. Un silenzio profondamente diverso da quello impenetrabile della montagna. Il silenzio del mare è poroso, si lascia attraversare dal fragore dell’onda, dalle vibrazioni prodotte dal vento tra le drizze, dalle strida dei gabbiani, dalle sirene dei traghetti. Questo silenzio ospitale filtra il rumore di fondo della città e libera l’ascolto selettivo e attento, rigenera le percezioni.
Lontano dalla costa, privati della presenza rassicurante del suo profilo e del miraggio di un porto, si può scoprire una nuova serenità nel muto, secolare, nuotare a fior d’acqua di una caretta-caretta o nel suono liquido e gentile del guizzo di un giovane delfino che gareggia con la prua.
Navigare a vela è navigare in un silenzio vivo, in movimento, senza il rumore del motore.
C’è la possibilità, navigando a vela, di imparare questa lezione. E servirsene per vivere.
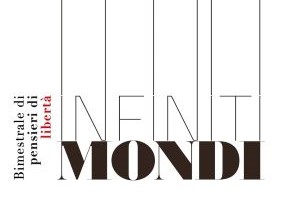



Brava, brava e … Brava ! Condivido tutto e mi commuove , hai scritto e descritto quel che ho sentito e sento quando alzo le vele.
Trovo quello che hai detto ciò che si vede e si sente nell’onda del mare🚣♀️👍